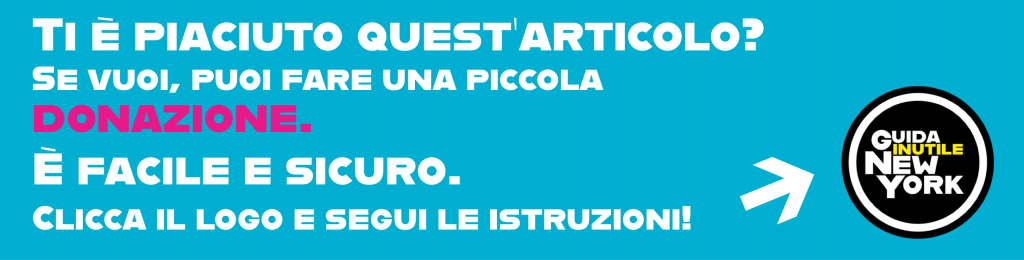La città che sta sveglia
Nightclubbing a Bushwick. Perché il sabato del villaggio arriva anche a New York, “la città che non dorme mai” (a meno che non sia lunedì)…
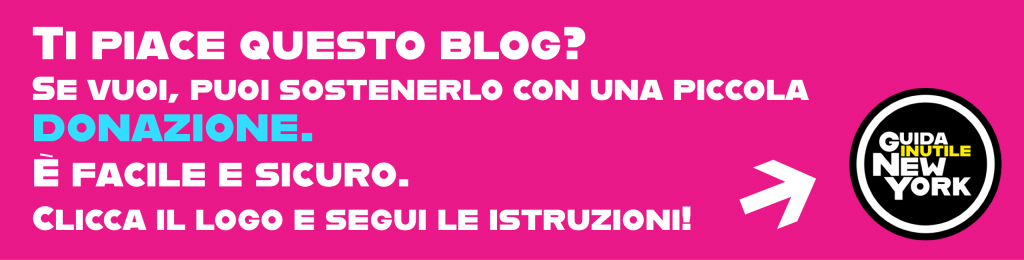
Domenica 27 marzo, ore 09.28
C’è uno zombie a casa mia. Si avvicina a mio figlio, gli passa una mano tra i capelli, sfiorandolo appena, mentre il ragazzino è ancora seduto al tavolo per la colazione e guarda Scooby Doo su uno schermo portatile, di quelli che lo zombie, alla sua età, se li poteva solo sognare. Allo stesso tavolo c’è anche la Ragazza dai Capelli Rossi, mia moglie. Saluta lo zombie con un buongiorno e un sorriso raggiante. Non so se devo iniziare a preoccuparmi. Lo zombie le dà un bacio sulla fronte e dice qualche parola incomprensibile. Forse ricambia, forse parla di caffè.
Quello zombie sono io. Almeno non ho ragione per essere geloso.

Venerdì 25 marzo, ore 18.35
Quante volte ho già ripetuto che dovrei andare a fare una passeggiata prima di cena? Perché sono ancora a casa? Gab, ti stavo pensando. Ti ricordi quando a Roma andavamo a ballare al Brancaleone? E quando finivamo le serate al fondo di Via Cernaia con la “sorchetta doppio schizzo”, quella fenomenale girella ricoperta con panna liquida fredda e poi cioccolato caldo? No, non ti dico niente di tutto questo. E non ci culliamo nemmeno più nella nostalgia dei tempi in cui perdevamo la testa tra Pistoia e Benevento. Ti faccio solo gli auguri e tu mi dici che salumi, formaggi, vini e dolci ti lasciano un conto sempre più pesante. Ti stavo pensando perché sto cercando un Brancaleone a Brooklyn. Ma tu eri pratico anche della vita notturna torinese di fine Anni Novanta, quindi se ti dicessi Doctor Sax o Giancarlo tu capiresti al volo. Anche Docks Dora, prima che diventassero un quartiere degli Anni Cinquanta.
Ho promesso al mio amico medico, quello che riconosce le macchie di sangue sul marciapiede, che prima del suo rientro definitivo in Italia lo avrei portato a fare un po’ di vita notturna qui a New York. Ho capito che vorrebbe provare uno di quei grandi disco club alternativi, che a Manhattan non esistono più e adesso bisogna attraversare l’East River. Lui ha in mente la House of Yes a Bushwick, di cui ha letto anche sulla Lonely Planet. È un locale popolare, soprattutto tra la grande comunità LGBTQ+ cittadina, con serate a tema e dove in genere i costumi sono di rigore per poter entrare.
Potremmo anche andare a Williamsburg. Tra bar, pub, ristoranti, diner, caffè, club e cazzi vari, il quartiere è sempre più simile all’East Village delle strade con locali appiccicati gli uni agli altri. Solo un ponte separa i due quartieri. Da lì, seguendo alcool e musica, si può anche tracimare a Greenpoint e, soprattutto, a East Williamsburg. Ma è Bushwick il posto giusto. La Brooklyn underground, che poi vuol dire tutta la New York underground, è laggiù. Una landa industriale, con magazzini più o meno grandi, trasformati in sale concerti, gallerie, discoteche e dispensatori di cocktail.
Un’occhiata veloce, troppo veloce, alla bibbia musicale “Brooklyn Vegan”, giusto per essere certo che domani non ci perdiamo il concerto del secolo. Basta con i tira e molla. Ho preso la mia decisione. Prima andremo a bere qualcosa al Jupiter Disco, e poi punteremo all’Elsewhere per finire la notte ballando a più non posso. L’importante è crederci. “Don’t stop believing”, lo sapeva anche Tony Soprano.
Sabato 26 marzo, ore 21.48
Ho detto a Ben che alle 22.00 passo a prenderlo. Dal divano intuisco a malapena i numeri dell’orologio in cucina. Pare che manchino solo 12 minuti prima d’arrivare a casa sua. A questi devo però aggiungere almeno 15 chilometri, e non riesco a trovare la frizione tra i cuscini rossi. Sono stanchissimo, ho la testa pesante, come se avessi passato un intero pomeriggio a giocare a scacchi. No, quello l’ha fatto mio figlio, ad un torneo per raccogliere fondi da spedire ai rifugiati ucraini. Io ho soltanto passato il pomeriggio ad aspettarlo, vagando per tutto il Village e dintorni, da est a ovest, sotto il sole, la pioggia, e poi la grandine e poi di nuovo il sole. Comprando ogni genere di patatine al gusto di gamberi, frittatine coreane, riso per il sushi e spazzolini giapponesi. Sciacquando la bocca con un caffè Vergnano, per non dimenticare mai Torino. Poi i soliti tre quarti d’ora per tornare a casa, e preparare la cena, e mangiare carbonara come fossi uno e soprattutto trino all’ultima cena, e poi perdere conoscenza sul divano.
Caffè, tanto caffè, o non arrivo a mezzanotte. Ho poi anche urgente bisogno che il gusto di caffè mi ricordi che ho bevuto quel caffè proprio per essere sveglio. Si, il gusto in bocca mi deve rimanere. Cazzo lavo a fare i denti, ché tanto non ho in programma di baciare delle perfette sconosciute.
Sabato 26 marzo, ore 22.30

Ho detto a Ben che alle 23.00 sono da lui. Per ora, insieme al resto dell’universo mondo, sono invece quasi a passo d’uomo sulla BQE, come quaggiù chiamiamo affettuosamente la Brooklyn-Queens Expressway. Sette minuti per fare poco più di un chilometro e mezzo. Stasera non è lunedì. Cerco di fare uno scatto del panorama di Manhattan, proprio perché so che poi mi servirà per la Guida. Viene fuori, oggettivamente, una bella cagata.
Dal Ponte di Brooklyn butto l’occhio sull’autostrada FDR che costeggia l’East River, e il traffico sembra scorrevole. Il cuore oltre l’ostacolo, invece, l’ho già scaraventato quando ho deciso di non rimanere a casa a dormire sul divano dopo l’indigestione di carbonara. Prima mi lamento degli ignavi senza coraggio e poi cerco io una scusa banale per rimandare? Non sia mai. Piede sul pedale e via.
Sabato 26 marzo, ore 23.04
Signore e signori, ce l’ho fatta. Mi lascio alle spalle la FDR e le Nazioni Unite, e sono sotto casa di Ben quasi in perfetto orario sull’ora di ritardo. Lo sapevo, adesso è lui che sbadiglia. “No, no, sono a posto. Grazie per essere venuto a prendermi. Andiamo!” Non posso nemmeno sfotterlo più di tanto, perché non è che anch’io abbia più tutta ‘sta resistenza. Ho perso l’abitudine alle serate danzanti, quelle che con Paoletta e Papa Ciccio andavano avanti fino alle ore antelucane. L’ultima volta che sono andato a ballare qui a New York è stata la bellezza di cinque anni fa. Ho visto Pete Tong al Brooklyn Music Festival. Venti minuti a piedi da casa mia, uno spettacolo. Adesso, invece, devo macinare almeno altri dieci chilometri in macchina, tornando nella direzione da cui sono arrivato.
Prendiamo il Queensboro Bridge, e non voglio immaginare quanto debba essere letale quest’asfalto per i piedi dei maratoneti di novembre. Puntiamo verso il cimitero di Calvary e passiamo poi sotto il nuovo Kosciuszko Bridge, che cambia continuamente colore come fosse pure lui una discoteca. A meno di non voler allungare i tempi, e seguire il discreto senso dell’orientamento del mio naso, fidarsi ciecamente di Google Maps è la scelta migliore. Ci fa attraversare aree industriali semi-deserte, e ci fa pensare che se la macchina si fermasse qui saremmo spacciati. Comunque, tenuto conto dell’ammontare di pistole in città, e delle teste calde che le portano appresso, anche solo litigare con qualcuno di questi gangster alla guida potrebbe costare caro in questa calorosa città. Insomma, meglio tenere gli occhi aperti. Welcome to New York.
Arriviamo finalmente su Flushing Avenue. Passiamo davanti al Knockdown Center, siamo ancora nel Queens. È una vecchia fabbrica riconvertita in ampio centro culturale per mostre, concerti ed eventi vari. Ci sono stato una sola volta, con tutta la famiglia e quando il piccoletto era ancora in età da passeggino. Pensavo che stasera fosse chiuso, invece vedo gente che entra e il cortile è pieno. Chissà cosa c’è in programma…
Decidiamo di lasciare la macchina poco oltre, sempre lungo Flushing Avenue, perché non ho idea della situazione parcheggi qui in zona. Ci sono vie zeppe di locali, come Wyckoff Avenue e dintorni, dove è impensabile trovare un buco libero e la gente arriva con la metro L. Sono solo cinque minuti a piedi ma l’aria è gelida. I vecchi, a quest’ora, non dovrebbero essere in giro. Ma noi siamo vecchi che hanno una concezione alternativa anche del buon senso.
Lunedì 28 marzo, ore 19.06
Ma che fine ha fatto la primavera? Lo sapevo che il caldo estivo di settimana scorsa ci avrebbe fottuto. Qui a New York la primavera arriva solo a fine aprile. Altroché l’aria gelida di sabato sera… Il termometro oggi pomeriggio è sotto zero. Se non mi sbrigo a tornare a casa, ‘sto vento mi sta bucando la fronte, non c’è berretto che tenga… E poi il sole del tramonto, che colori… E pure ‘sti piccoli fiocchi di neve… Che follia… Ma poi perché sto parlando del tempo?? Perché quello folle sono io, maledizione. Sabato sera, al Knockdown, suonavano gli LCD Soundsystem, per il tour del loro ventennale. E noi ci siamo passati davanti. E i biglietti costavano solo una settantina di dollari. Solo.
Sabato 26 marzo, ore 23.48
Arriviamo davanti al Jupiter Disco, yeah. Non esiste insegna, solo una luce al neon viola. Non può che essere il Jupiter, perché abbiamo camminato i cinque minuti di cui sopra. C’è la coda per entrare, perché a New York si fa la coda praticamente per tutto, anche davanti al cesso di casa tua. E avremmo potuto parcheggiare qui di fronte, ovviamente.

“Scusate, sapete se questo è il Jupiter?”, mi chiede un ragazzo, mentre tiene in bella vista il suo telefono, e io mi chiedo invece se questo allegro giovinastro sia l’unico essere umano che non sappia usare Google. “Oh, si, è il Jupiter”, gli rispondo squillante. Poi mi avvicino a lui. “In realtà, non sono mica certo. Ma ti avrei comunque risposto si.” Mi guarda un po’ perplesso, sta cercando di abbozzare un sorriso mentre mi dice ok. Non credo abbia capito il mio tono ironico, e io cerco di trattenere in prigionia tutti i pregiudizi che mi erano saliti all’orecchio appena avevo udito il tono della sua voce.
Santi numi, se è dura ammazzare i nostri pregiudizi. Una cosa però è vera: la metà dei giovani alternativi che gira per i locali di New York sono universitari che arrivano da fuori città, e di newyorchese hanno solo l’indirizzo dove ricevono i pacchi da mamma e papà. Zero senso della battuta, soprattutto di quelle più brutali, come ti aspetteresti invece da veri newyorchesi abituati ad una città che non te la manda mai a dire. E sarebbero così privi di umorismo anche se nelle loro aule non fossero educati a riconoscere la più infinitesimale delle “micro-aggressioni” ai danni di qualunque gruppo considerato ai margini della società. Spero almeno che abbiano trovato un modo per trombare, di questi tempi magri. Se non ci si fosse messa la pandemia, ci sarebbero comunque le regole d’acciaio adottate da tutti i locali notturni, dove qualunque atteggiamento eccentrico può rischiare di diventare una molestia. Buona fortuna. Io, nel caso, terrò le mani ben in vista, strette al petto a mo’ di insetto e non mi sognerò di profferire parola, ché vista l’età media dei giovani avventori…
In coda davanti a noi c’è una ragazza che sta leggendo un libro. Complimenti a lei, davvero. Sconsiglio a Ben di avvicinarsi troppo per capire cosa stia leggendo, proprio perché tra scarso senso dell’ironia, ed estrema sensibilità verso l’approccio alla sfera personale (mettiamola giù così), non vogliamo finire nei guai prima di mettere piede dentro la nostra meta.
Il buttafuori, ad alta voce e più volte, ricorda a tutti quanti che il biglietto d’ingresso va pagato in contanti o con Venmo (un’applicazione simile a Satispay, ma che funziona anche con semplice bancomat o carta di credito). Il Jupiter è un bar e il registratore di cassa è solo al bancone, non anche alla porta d’ingresso. La ragazza del libro entra, mentre noi siamo ancora lì ad aspettare. “Siamo anziani,” dico al buttafuori, “vorrai mica averci sulla coscienza…” Sorride, ma non si fa intenerire.
Domenica 27 marzo, ore 00.11
Arriva il nostro turno, la porta di Giove si spalanca davanti noi. Un piccolo corridoio ci porta dentro l’altrettanto piccola disco-astronave. Grande impianto sonoro, invece, e isolamento perfetto: dalla strada non sentivamo una nota che fosse una.

Bello, bello, bello. Io sono già innamorato del Jupiter Disco. È esattamente come me lo immaginavo, come i locali che sono sempre piaciuti a me, dalle dimensioni ridotte, intimi, di quelli dove devi accettare di sudare con gli altri ed è impossibile nascondersi dietro una colonna, perché non ce ne sono. Certo, avevo un quarto di secolo in meno quando apprezzavo tutta questa prossimità. E mai nessuno di noi spensierati pivelli avrebbe immaginato, in quell’epoca innocente, che il Covid non fosse qualche nuovo acronimo dell’Agenzia delle Entrate ma un virus capace d’uccidere. Sempre anni fa, anche in vacanza a Londra ho fatto carte false per andare in un club poco più grande di un garage, solo perché era in programma una serata con alcuni dj della Ministry Of Sound.
Qui dentro al Jupiter Disco siamo tutti senza mascherine, perché la nuova variante di Omicron a noi non turba il sonno. In questo bar si potranno pigiare non più di un centinaio di corpi, e la luce viola dominante sembra fatta apposta per farti volare invece nelle orbite dello spazio interstellare distante anni luce da Bushwick. Attaccato al soffitto c’è uno schermo grande come un televisore, dove puoi leggere il menu dei cocktail. Il carattere e il suo colore verde forse vogliono richiamare alla memoria i vecchi computer che usavano alla Nasa ai tempi di Armstrong e Aldrin sulla Luna. Anche le dimensioni del ghiaccio nel mio Negroni ricordano quelle di un meteorite, ma non posso lamentarmi.
Il nostro DJ si chiama M50 e arriva da Chicago. Non so come definire la sua scaletta musicale, perché sono lontani i tempi in cui mi tenevo aggiornato leggendo Mixmag. Ma direi che abbondano house ed elettronica varia, come garba a me (Gab, il “garba” è in tuo onore). Ben si piazza in un angolo e osserva attentamente, con in mano la sua bella birra d’ordinanza. Ovviamente, per parlarci dobbiamo strillare. Mi racconta che mesi fa, in un altro locale, lo hanno scambiato per un addetto alla sicurezza. Io, invece, mi faccio ben presto prendere dal ritmo e inizio a ballare. Sono arrugginito, nei miei movimenti. La Ragazza dai Capelli Rossi dice che, come la quasi totalità dei bianchi, non ho senso del ritmo (lei non soffre della stessa malattia, perché componeva musica). Me ne faccio una ragione. Tra l’altro, la mia t-shirt dei Criteria Studios di Miami è proprio fighissima. E anche se ballo con tutta l’asincronia possibile, sono fighissimo pure io. Ma questo lo sapevo già. Come rammento spesso con una battuta a mia moglie, nel mio passato si creavano le code per… vabbè.
Domenica 27 marzo, ore 01.20
Siamo di nuovo all’aria aperta, dopo appena un’ora di nightclubbing. Breve ma intenso. Non me la sento di costringere Ben a rimanere ancora un po’, e tantomeno andare a Elsewhere: lui è visibilmente stanco e io sono contento della mia sgambata a passo di house. Torniamo a recuperare la macchina e l’alcool ci aiuta con la percezione del freddo. Porto Ben a fare un breve giro dentro il cuore di Bushwick, districandoci tra gli Uber in doppia fila. Da Flushing Avenue, dove si trova il Jupiter Disco, non era riuscito a farsi un’idea del quartiere. Soprattutto, non capiva cosa attirasse migliaia di giovani in questo luogo a prima vista così tanto desolato. Adesso, accasciato sul sedile del passeggero, può vedere alcuni dei locali e dei nightclub di cui gli avevo parlato, dalla House of Yes, che rimarrà il suo cruccio, sino a Elsewhere. Se cerchi Berlino a New York devi venire qui a Brooklyn, perché a Manhattan la New York underground non esiste più.

Tra l’altro, a proposito di “underground, mooolto underground”, come avrebbe detto l’Epifanio di Antonio Albanese. Un paio di note lessicali. In America, per esprimere l’idea di alternativo in fatto di musica o locali, si può dire “DIY”, che è l’acronimo di “do it yourself” (fallo da te), e richiama il concetto di qualcosa che non cala dall’alto ma è prodotto da una comunità di persone; oppure si può usare proprio il termine “underground”. Tutti i locali dove si ascolta musica dal vivo o suonata da dj si chiamano “nightclub”, e non hanno nulla a che vedere con l’idea italiana di luoghi per soli uomini.
Domenica 27 marzo, ore 02.20
Google Maps voleva semplificarmi l’esistenza, ma io volevo invece complicarmela. Mi sono distratto sulla BQE e ho perso di vista un cartello gigantesco con la scritta “Manhattan – Midtown Tunnel” a caratteri cubitali. Questa volta ci siamo ritrovati non sotto, bensì sopra il Kosciuszko Bridge che unisce Brooklyn e Queens. Ben non era arrabbiato, anzi. In effetti, di sera e con le luci colorate che cambiano ogni minuto, si tratta di un ponte davvero suggestivo. Abbiamo allungato un po’ la strada, ma tant’è. Per fortuna di Ben, almeno non ho perso l’uscita del Williamsburg Bridge per andare nella Lower East Side.

Dopo aver finalmente liberato il mio amico, e averlo riaccompagnato a casa, ho imboccato 2nd Avenue e adesso sono arrivato nel bel mezzo della più tradizionale vita notturna di New York: l’East Village. Non sono stanco, ma non ho intenzione di fermarmi. Da solo, in questi locali per gggiovani, sembrerei ancora più vecchio dei miei gloriosi 53 anni. Ho altri piani, invece. Voglio una boccata d’aria fresca e voglio guardare la mia città da lontano. Un po’ come quando vivevo a Torino e finivo le mie serate salendo al Monte dei Cappuccini. A volte lo faccio ancora quando ci ritorno per le mie brevi trasferte italiane.
Il traffico si muove lento ma procede. Supero Houston Street, prendo la Bowery e giù per il Manhattan Bridge. Nel mio continuo zig-zag tra i ponti sono di nuovo a Brooklyn.
Domenica 27 marzo, ore 02.40
Faccio una deviazione da Flatbush Avenue e giungo a Brooklyn Heights, per la mia ultima tappa prima di rientrare a casa dopo la nottata a Bushwick. Su Montague Street, la via centrale di questo ricco quartiere residenziale, c’è una macchina della polizia con i lampeggianti accesi. Parcheggio al fondo della via. Giusto due passi e sono sulla promenade. Come immaginavo, e come desideravo, è completamente deserta. Sono l’unico matto ad essere qui a quest’ora della notte, non c’è altra anima viva. Anche se solo per cinque minuti, ché fa davvero freddo e non sono vestito pesante, voglio però fermarmi e sedermi su una panchina. Davanti a me c’è Manhattan, tutta illuminata in una delle sue cartoline più riconoscibili anche a chi non abbia mai messo piede a New York. Non sono più in movimento, come a inizio di questa lunga serata, ma la mia foto non rende ugualmente giustizia al panorama.

Mi appoggio alla balaustra che mi separa dalla caduta libera sull’autostrada sottostante, e lascio invece che i miei pensieri vadano per un po’ in libera uscita.
Scatto ancora un paio di fotografie e poi infilo di nuovo le mani in tasca. Adesso sento davvero freddo. Fra un po’ mi rimetto in macchina e in altri venti minuti sarò a casa. Meglio: sarò a cercare parcheggio. Quando aprirò la porta di casa, è un’altra storia.
Ma sono felice, è stata una gran bella serata. E questa, si, è comunque una splendida notte. Una buona, splendida notte.
Qualche idea per il vostro nightclubbing a NYC