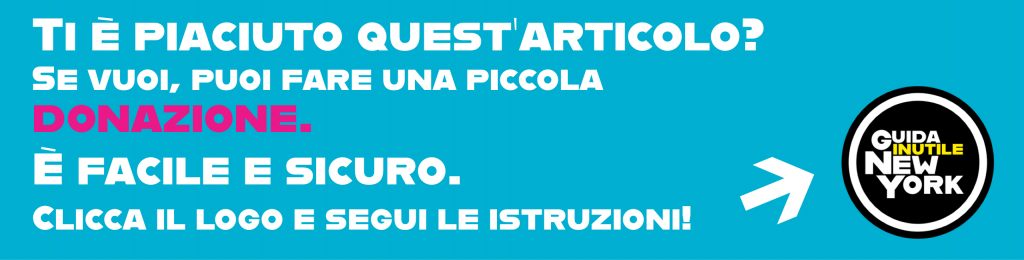Da New York a Miami, in c**o a Jupiter
Un newyorchese che si mette in viaggio per Miami è come un milanese che va in Liguria. Ma poiché l’America è un bel po’ più lunga, ha troppo tempo per guardarsi attorno, e per riflettere sul suo Paese…
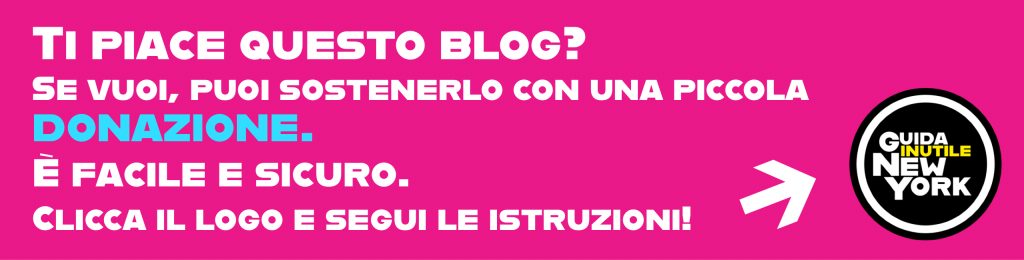
Tutto è sempre molto relativo, si sa. Quando l’amico Luca mi manda un messaggio per sapere se sto per arrivare a Miami, gli rispondo che sostanzialmente sono quasi arrivato, che sono già oltre Melbourne. No, non la metropoli australiana dove ogni anno si gioca uno dei quattro tornei di tennis del Grande Slam. Quella, di sicuro, è lontana come Giove e il suo famoso fondoschiena. La mia Melbourne si trova invece nella contea di Brevard, una delle 64 da cui è composta la lunghissima Florida. Si, la Florida non sarà immensa come il Texas, ma manco lei scherza quanto a dimensioni. Puoi viaggiare per un giorno intero, ed essere ancora dentro il Sunshine State e in un diverso fuso orario: perché da un estremo all’altro, da Key West a Pensacola, ci sono più di 1200 chilometri. Melbourne è a circa 250 chilometri dalla mia meta finale, North Miami Beach. In America il limite di velocità impone di non superare, quando ti dice bene, le 70 miglia orarie, che è come dire 110km/h. Quando facciamo i pazzi, e vogliamo farci ritirare la patente dalle polizie locali in agguato su ogni autostrada per far cassa con le macchine che arrivano da un altro Stato, sfrecciamo a 80-85, cioè la bellezza di 130-135Km/h. Tenuto conto del maggior traffico all’interno della sterminata area metropolitana di Miami; della stanchezza dopo un’intera giornata trascorsa al volante; e poi della necessità di almeno un’altra sosta per la periodica minzione, da Melbourne a NMB (come i “locals” chiamiamo affettuosamente North Miami Beach), mi servono due ore e mezza per coprire quello che è l’ultimo tratto del mio interminabile viaggio. Alla faccia del sono quasi arrivato.
“BELLA MILANO, SI SE PUTESS’ VEDÉ” IL MARE
Gli americani hanno un concetto di distanza molto diverso rispetto agli europei. Qualche anno fa, durante una cena a Miami a casa di conoscenti ormai in pensione, e con la passione per l’Italia, fui sorpreso dalla loro idea di prossimità. Consideravano Milano vicinissima al mare. Per qualche istante avevo pensato che si riferissero ai Laghi. “No, no”, avevano replicato senza esitazione, “le Cinque Terre, in Liguria”. La concezione americana degli spazi non ha nulla a che vedere con l’adozione del sistema di misurazione imperiale britannico, contrapposto a quello metrico decimale. È l’immensità della geografia in America che abitua all’idea di distanze siderali per qualunque italiano. A New York, già solo sotto il Ponte di Brooklyn, un fiume insignificante come l’East River è largo mezzo chilometro. Sotto il George Washington Bridge, che connette New Jersey e New York, le sponde del fiume Hudson sono separate da poco più di un chilometro. Un newyorchese che si mette in macchina per coprire gli oltre 2000 chilometri di autostrada tra Brooklyn e Miami, deve prepararsi ad almeno due giorni di viaggio (che in genere diventano tre) e ad attraversare lunghi ponti e tunnel. La campata del Memorial Bridge che sovrasta il fiume Delaware poco dopo Wilmington si estende per due chilometri. Pure un fiume sconosciuto come il Susquehanna in Maryland, ignoto anche a milioni di americani, ha il suo ponte sospeso per quasi un chilometro e mezzo. E i due tunnel che attraversano la baia di Baltimore hanno una lunghezza compresa tra il chilometro e il chilometro e mezzo. Di fronte alla vastità degli spazi americani, anche un viaggio di duemila chilometri diventa banale e scontato.

Quello che frega noi europei immigrati qui in America è il limite di velocità, decisamente basso per i nostri parametri alla Clay Regazzoni (sempre pace all’anima sua). Anche gli americani sono refrattari alle regole. Anzi, a ben vedere, amano e reclamano la loro libertà con toni perentori e atteggiamenti di aperta ribellione impensabili per il paternalismo del Vecchio Continente. Ma avendo limiti di velocità più rigorosi, e più controllati da pattuglie della polizia che in un niente sbucano dai boschi, le strade americane sono in media meno pericolose di quelle italiche. Anche quaggiù si vedono incidenti gravi, ovvio. Si vedono però soprattutto nelle autostrade che tagliano le metropoli, perché si tratta spesso di arterie più strette e tortuose. Ogni giorno, tenuto conto della mia localizzazione (ciao ciao, riservatezza), ricevo messaggi di incidenti qui a New York sulla Brooklyn-Queens Expressway e sulla Gowanus Expressway. Gli attraversamenti autostradali urbani di Richmond, in Virginia, e di Jacksonville, in Florida, sono i più spericolati dove finora io abbia mai guidato un’automobile. Ci ho visto incidenti e altri li ho evitati solo per questione di minuti. Sono luoghi dove il limite di velocità, proprio a causa dell’alto volume di traffico, e la dimensione parzialmente più ristretta delle carreggiate, è tra le 55 e le 65 miglia orarie (circa 90-100Km/h). Gli abitanti non rispettano quasi mai queste restrizioni. Ma una volta fuori dalle aree urbane, dove si praticano velocità meno estreme rispetto ai limiti legali, e le strade sono più ampie, si viaggia in maggior sicurezza ed è molto più raro imbattersi in incidenti drammatici. Il prezzo di una maggior sicurezza lo paghi in ore di viaggio. Anche a non fermarsi mai, con una media di 120km/h ti servono almeno 10 ore per fare la stessa distanza che c’è tra Torino e Santa Maria di Leuca.
NEW YORK – MIAMI, LA GITA FUORI PORTATA
È con questi numeri in testa che io, ogni volta, mi accingo all’epica cavalcata tra New York e Miami. La ragione delle mie frequenti trasferte nella città più famosa della Florida è semplice: laggiù è nata ed vissuta mia moglie, e a Miami riposano adesso in pace i suoi genitori. Si tratta, in genere, di un viaggio che coinvolge tutta la famiglia, anche se sono io l’unico a guidare. Conoscendo la mia tendenza all’occhio pesante post-prandiale, mia moglie si premura sempre di tenere la mia panza leggera e di preparare piccoli panini che io posso mandare giù in soli tre bocconi, anche mentre sono al volante. Mio figlio sa che deve comunicare per tempo se non riesce più a controllare la sua vescica e che le mie capacità divinatorie in merito si sono esaurite nel momento in cui abbiamo abbandonato i pannolini. Sa inoltre che un viaggio tanto lungo e noioso gli offre un generoso lasciapassare sull’uso del tempo libero. Leggere, disegnare e scrivere un minimo sono attività sempre richieste, se non vuole incappare nell’ira genitoriale funesta. Ma pur di non aver qualcuno che si lamenti in continuazione, o chieda con altrettanta costanza l’orario d’arrivo, siamo disposti a lasciarlo di fronte ai cartoni animati per un tempo che a casa sarebbe proibito. Fortunatamente, a 8 anni e mezzo non sa ancora cosa siano i videogiochi. E per due giorni, in assenza di collegamento internet in macchina, si deve dimenticare di giocare a scacchi con mezzo mondo. Può invece mettere becco sulle scelte musicali, anche perché su Skiantos, Roots e Daft Punk c’è consenso unanime.

Che succede quando invece la famiglia non è al seguito? In genere faccio viaggi più brevi, che si protraggono solo dall’alba a notte fonda oppure per due o tre giorni. Sono spostamenti sopportabili, perché mi fermo spesso o perché le distanze sono ridotte. Ma l’idea d’andare a Miami da solo è di quelle che abbassa le palpebre ancor prima di schiacciare la frizione e partire. Che succede se ti prende la noia? E se inizi a sbadigliare, basta il finestrino spalancato? E puoi metterti a parlare tra te e te? E se non vuoi o non puoi fermarti, ma non riesci a raggiungere la cioccolata? Per non parlare del Covid. Adesso, giustificato o meno che sia, ci hanno instillato il terrore di poterci ammalare mentre andiamo al cesso o quando dormiamo nella stanza di un albergo dove qualcuno prima di noi potrebbe aver soggiornato e sparso il virus ai quattro venti. Caffè, acqua, musica, mandarini, mascherine, arachidi, disinfettante per le mani. Nel 2021 serve una preparazione nei minimi dettagli. Se pensate che stia esagerando, vuol dire che non avete mai fatto duemila chilometri in due giorni. Oppure che guidate autotreni per lavoro, e allora con voi non c’è competizione. Anzi, di fronte a voi mi inchino e c’è massimo rispetto. Seriamente. Se qualcuno desidera criticare chi passa la sua esistenza a guidare camion per portare a casa vostra tutto quello che vi sta circondando in questo preciso istante, è libero di farlo, e di portare il santino di Greta nel portafoglio. Ma sappiate che chi scrive è sempre di più un ammiratore sincero di chi fa un lavoro così massacrante e fondamentale. Anche in America, dove storicamente le ferrovie hanno avuto un ruolo importante nello sviluppo economico, le merci viaggiano soprattutto su gomma. Perché è l’unico modo per raggiungere tutti, ma proprio tutti gli americani, in ogni angolo sperduto, sia esso un quartiere isolato o un paesino di montagna. Negli Stati Uniti il 70% delle tonnellate di merci varie, e del loro valore, viene trasportato da autotreni, camion e furgoni. Quando si pensa invece in termini di tonnellate per chilometro (perché lo so che voi avete ‘sto chiodo fisso), anche la ferrovia fa la sua parte, con quasi un terzo del totale merci; ma comunque a fronte di oltre il 40% trasportato su gomma. Insomma, se avete le patate al mercato sotto casa o i cerotti in farmacia, ringraziate qualcuno che passa la giornata al volante.
PRONTI, PARTENZA… VIA?

Il commiato prima della partenza è lungo, perché lunghi saranno i giorni lontano dalla Ragazza dai Capelli Rossi e dal mio Piccoletto. L’idea di partire alle 7.30 diventa la certezza d’essere già fortunato se riuscissi a partire alle 9.30. Più che un commiato, è un continuo rinvio di cose insignificanti che potrebbero farsi in dieci minuti invece delle due canoniche ore. Come già solo allontanarsi senza strazio dal focolare non mandasse all’aria ogni buon proposito di partenza antelucana, uscire dall’area di New York è sempre un terno al lotto. Certo, con il navigatore del tuo telefonino puoi controllare il traffico e verificare la presenza di incidenti. Ma non avrai mai a disposizione un gran ventaglio d’alternative: la quasi totalità dei newyorchesi vive su isole (a parte i residenti del Bronx, gli unici tra noi a vivere sulla terraferma) e tutti devono comunque attraversare fiumi se vogliono muoversi verso sud e ovest. Nel mio caso, il Ponte di Verrazzano è una strozzatura inevitabile; così come, una volta raggiunta Staten Island, sarà inevitabile incanalarsi nel Goethals Bridge. Quand’anche il traffico fosse scorrevole, e non vi fossero restringimenti di carreggiata, il limite di velocità sui ponti è ridotto per ovvie ragioni di sicurezza, in quanto le corsie sono meno ampie, il vento nella baia spazza sempre con vigore, e un incidente sui ponti si tradurrebbe in incubo. Se tutto va bene, ma proprio bene, bene, i primi 30 chilometri in autostrada, quelli che ti portano finalmente sul NJ Turnpike, li puoi fare nel tempo record di trenta minuti. Nel frattempo, e ringraziando la sorte benevola, avrai già pagato 6 dollari per i 1300 metri del Verrazano Bridge, mentre i 16 dollari del Goethals li pagherai solo al ritorno. Non perdere tempo a cercare alternative meno costose, perché non esistono. A meno di non emigrare da New York una volta per tutte, il transito dal New Jersey costa sempre 16 dollari. Così, sarà inutile andare a Manhattan e da lì prendere l’Holland Tunnel, che è gratis solo in uscita da New York e si paga invece al ritorno. Vero che si possono risparmiare in totale i 12 dollari del Verrazzano, perché il Ponte di Brooklyn e quello di Manhattan sono ancora gratis; ma si aggiungono miglia inutili e altrettanto inutile stress da traffico. Attraversare Canal Street a Chinatown, per andare dal Manhattan Bridge all’Holland Tunnel, è un mal di testa anche alle 4 del mattino, fidarsi. Quaranta chilometri in un’ora, per arrivare allo stesso punto di prima e aver risparmiato i 6 dollari della sola andata? Non scherziamo. Questa è l’America, e i dollari abbondano.
Una volta imboccato il New Jersey Turnpike, e cioè il tratto locale della lunga autostrada I-95 che mi condurrà a Miami, è lì che si materializza la vera pacchia. Di fronte a me ho ben sei corsie, divise in due carreggiate, una delle quali dedicata esclusivamente alle automobili. Tutto oro che cola? Niente affatto. Il limite di velocità è di 65 miglia all’ora, cioè poco più di 100km/h, un’andatura estremamente lenta per una strada con corsie tanto larghe. Il guaio inizia nel momento in cui decido di rispettare rigorosamente il limite. Io e la mia coscienza, e pure il mio innato senso civico, ci sentiamo alla grande, rispettosi delle regole sociali di buona convivenza. Ma arrivare alla prima pausa pipì richiede più di due ore in cambio di 200 miseri chilometri. È gia mezzogiorno. Tra partenza continuamente rinviata, e andamento lento, sono in ritardo sulla tabella di marcia. Ho appena macinato 128 miglia sulle 630 programmate per arrivare a Florence, in South Carolina. I mille chilometri al giorno che avevo in testa stanno già andando a farsi benedire. Il New Jersey Turnpike, poi, non è nemmeno tutto rose e fiori. Arrivati a Trenton, la capitale di quello che è conosciuto come Garden State, le corsie per senso di marcia si riducono a tre e poi, dopo una ventina di minuti, ti ritrovi con sole due corsie fino al Delaware Memorial Bridge che attraversa l’omonimo fiume per condurti nell’altrettanto omonimo Stato del Delaware. Sono nella patria del Presidente Joe Biden. La capitale Wilmington, che la mia autostrada tocca tangenzialmente, è la sua città natale, ed è pure il luogo dove la sera delle Elezioni 2020 ha rilasciato le sue prime dichiarazioni. Il grande centro di benvenuto sull’autostrada I-95, l’area di sosta dove decido di fermarmi per fare pipì e aggiornare il mio Instagram con un autoscatto, si chiama “Biden Welcome Center”. Come se a Fanfani, ancora in vita, avessero dedicato una stazione di servizio sull’A1 dalle parti di Arezzo. Questa è una citazione per ultra-cinquantenni.
PENA CAPITALE

Dopo il New Jersey e il piccolo Delaware, è la volta del Maryland. I limiti di velocità non cambiano, sempre 65 miglia all’ora. Ma in Maryland la Interstate 95 torna a tre corsie per senso di marcia, è meno piatta, e c’è pure qualche curva, il che contribuisce a rendere il viaggio meno alienante. Soprattutto, in Maryland ci sono gli autisti peggiori che si possano incontrare su questa lunga autostrada che va da Boston a Miami. Sono loro che ti tengono sveglio, perché sono spericolatissimi e viaggiano a velocità spesso sconsiderate. Mentre tu sei lì che provi a stare di poco sopra i limiti, magari attorno alle 70 miglia orarie, loro si sparano le 90 come se niente fosse. Ci sono macchine della polizia a pattugliare, e qualche volta sono in borghese. Però, come da tradizione americana, gli unici polli ad essere fermati sono quelli che hanno una targa da fuori Stato. Quando il federalismo e i trasferimenti fiscali non sono sufficienti a livellare gli squilibri economici tra gli Stati, quaggiù viene sempre in soccorso la cara e vecchia multa all’automobilista di passaggio nella cinta daziaria.
Baltimore è la città più grande del Maryland, e nella sua area metropolitana abitano circa 2 milioni e 700mila persone. Si trova a una cinquantina di chilometri da Washington, la cui vasta area metropolitana, divisa tra il vero e proprio Distretto di Columbia (cioè la Capitale, D.C.), la Virginia e lo stesso Maryland, è popolata da almeno 6 milioni e 100mila persone. Tradotto in termini semplici, a beneficio delle vostre curiosità geografiche: per almeno 150 chilometri ti trovi a guidare lungo autostrade che attraversano una regione su cui insistono qualcosa come 9 milioni di esseri umani. In questo girone dantesco, il traffico sarebbe la pena anche se non si sommasse la peculiarità di Washington, cioè quella d’essere la Capitale Nazionale. Quest’ultima caratteristica rende ovviamente la città un magnete per traffico aggiuntivo di persone in arrivo da mezza America. Solo il coronavirus e lo svuotamento temporaneo degli uffici hanno reso più sopportabile guidare sulla Beltway, l’immensa tangenziale che circonda Washington. La Beltway non è solo famosa per i suoi interminabili ingorghi nelle ore di punta, che iniziano già alle due del pomeriggio come in ogni buona Capitale di fancazzisti che si rispetti. Quando in America si dice che qualcosa conta solo “dentro la Beltway” si fa riferimento a tutto quello che è importante esclusivamente per i politici, i funzionari del governo federale, i lobbisti e tutti i giornalisti che campano sugli intrighi e le lotte di potere che si combattono a Washington. È un’espressione che si usa per rimarcare la distanza astronomica tra il penoso circo della politica e la vita reale quotidiana degli americani. Un po’ come l’espressione che contrappone “Wall Street”, e cioè gli interessi corporativi della grande finanza, a “Main Street” (la principale via commerciale di ogni piccola città), vale a dire gli interessi delle persone comuni, dei piccoli commercianti e delle piccole imprese.

Da New York a Washington ci sono almeno 350 chilometri. Trattasi, grosso modo, di metà della distanza che esiste tra la Capitale Federale e Boston, cioè quella che è considerata la megalopoli del nordest americano. In sostanza, una sorta di unico grande ambiente urbano e suburbano dove vivono oltre 50 milioni di persone. L’area attorno a New York, con i suoi 20 milioni e rotti di abitanti è il fulcro di questo corridoio metropolitano, che quaggiù viene anche chiamato “Acela Corridor”, dal nome del servizio ferroviario ad alta velocità con il quale la Amtrak collega le principali città di questa macro-regione. Non è l’Alta Velocità a cui sono abituati i fortunati europei. Quando c’è grasso che cola, quaggiù vai da Penn Station a Manhattan a Union Station a D.C. in tre ore, toccando di tanto in tanto i 240km/h e per la modica cifra di 128 dollari, sola andata. Dice che un giorno non così lontano avremo pure noi la stessa ebbrezza che gli italiani godono tra Milano e Roma. Tenuto conto del traffico e dei limiti di velocità, quei 128 dollari sono ben spesi, per chi li ha e per chi vuole rientrare a casa la sera. Perché in macchina, per fare lo stesso tragitto, ti servono dalle cinque alle sei ore, senza considerare che poi devi trovare parcheggio e pagarlo a peso d’oro per ogni ora. Quando ho D.C. alle mie spalle, penso che sono già stanchissimo; che vorrei fermarmi per la notte a Richmond, in Virginia; che non arriverò mai in South Carolina, mai, mai, mai. Penso che essere ricchissimo sarebbe la giusta soluzione a tutti i miei problemi da Primo Mondo.
CAROLINA IN MY MIND

Da casa mia a Brooklyn fino a Petersburg, in Virginia, ci sono poco più di 570 chilometri. Come già detto sino alla noia, si tratta di un procedere relativamente lento, causa traffico e limiti di velocità. Ma a parte una cinquantina di chilometri alla fine del New Jersey Turnpike, quando la carreggiata si riduce a due corsie per senso di marcia, in genere hai almeno la fortuna di viaggiare su un’autostrada a tre corsie, quando non quattro o anche cinque. A Petersburg tutto cambia. All’altezza dell’uscita numero 50 trovi finalmente il primo cartello con l’indicazione “Miami”. Non fai a tempo a illuderti che sia un buon auspicio, che in poche centinaia di metri la tua strada si riduce a due sole corsie. Sta per iniziare la parte più complicata del mio viaggio. Fino al confine con la Georgia, la I-95 si snoda tra North Carolina e South Carolina su quelle stesse due misere corsie. È come fare 700 chilometri su una strada simile alla Torino-Piacenza, ma con il triplo delle macchine e con autotreni che, quando sorpassano altri autotreni, intrappolano tutti gli altri. Stesso discorso per chi guida piano, nonostante il limite di velocità diventi di 70 miglia all’ora e i controlli di polizia siano un po’ meno assillanti. Anche qui in America abbiamo la gloriosa tradizione di stare al culo di quelli che guidano lentamente, per mettere loro pressione e farli schiantare contro le altre auto che precedono. Ma non solo quest’usanza universale viene praticata ad un’andatura che qualunque tachimetro europeo considererebbe degna al massimo di un autoscontro; quaggiù non esiste il concetto diffuso di clacson e nemmeno quello dei fari abbaglianti. Se stai sorpassando come una lumaca, (quasi) nessuno ti farà mai i fari. Quelli, invece, si fanno per dare il via libera a immettersi nella tua corsia. Quando lampeggio i miei abbaglianti, per esempio, sto dicendo all’autotreno sulla mia destra che può iniziare a sorpassare l’autotreno ancora più lento che gli sta davanti. Solo in Florida, dove abbonda la stessa cultura latina aggressiva di noi italiani (dei pregiudizi parlerò a breve), qualcuno ha la pessima abitudine degli abbaglianti per farti spostare. In genere, se mi fanno i fari, il mio istinto è quello di: guardare nello specchietto, accelerare, cambiare corsia, far passare chi mi stava lampeggiando, mettermi io al culo del lampeggiatore, lampeggiare a mia volta, mostrare il dito medio. Il più delle volte, però, trattengo l’istinto. Perché l’America è decisamente più pericolosa dell’Europa, e mia moglie me lo ricorda tutte le volte che esco in macchina. Gli americani non sono più stronzi o violenti degli europei. Ma hanno più strumenti per farti male, anche quando tu pensi d’essere al sicuro, nel tuo abitacolo. Hanno più pistole, tante, tante di più. In Europa è pressoché impensabile leggere di incidenti stradali in città che si risolvono in sparatorie (così come leggiamo di colpi di pistola sparati da auto o moto solo in caso di agguati mafiosi). Qui in America non avviene di continuo, per fortuna; ma non è così raro o inimmaginabile. Due settimane dopo la mia calata solitaria, ho letto di un terrificante episodio avvenuto su un tratto della I-95 che conosco molto bene, nei pressi di Lumberton, proprio in North Carolina. Un uomo si trovava in macchina con sua moglie quando, per errore, ha fatto una manovra che ha tagliato la strada ad un’altra vettura, costringendola sulla corsia d’emergenza. A quel punto, il guidatore della vettura ha accelerato, sorpassato a destra e sparato all’indirizzo della macchina, per vendicare quello che ha considerato un affronto subito. Risultato? La donna è morta, e dopo due giorni la polizia ha arrestato il criminale, un uomo di 29 anni con precedenti penali per possesso illegale e uso di arma da fuoco.
Anche senza arrivare agli eccessi di crepare insensatamente, perché qualcuno ti spara mentre sei al volante, in periodo di feste comandate, tipo Natale o pausa primaverile delle scuole e università, quando arrivi in North Carolina sai che inizia il tuo incubo. Con o senza cantieri, ti può toccare di fare un paio di chilometri all’ora, e sei cosi disperato da cercare una qualunque via di fuga, anche quella che aggiunge un paio d’ore al tuo già interminabile viaggio. Tutto, ma proprio tutto, pur di non star praticamente fermi. Sono fortunato, perché a inizio marzo, e comunque sempre nel mezzo di una pandemia epocale che ha modificato un bel po’ di abitudini, il traffico in North Carolina è invece scorrevole. Il problema sono io. Questa prima giornata di viaggio non ne vuole sapere di finire. Sono stanchissimo, cotto. Continuo a ripetermi che, di questo passo a lumaca, arriverò a Miami per mangiare la colomba. Mi arrendo, e decido di fermarmi per la notte a Wilson. Sono le 8.30 di sera, e in undici ore ho macinato a malapena 750 chilometri. Disappunto.
NE AMMAZZA PIÙ LO SMOG DEL COVID
Presente quel mito per il quale era possibile addormentare i bambini piccoli cullandoli all’altezza dei fornelli col gas aperto? Non provatelo! Neanche per scherzo. Sperimentate invece qualcosa di simile su voi stessi. Meglio ancora se non siete nemmeno consapevoli di quel che state facendo. Il metodo che seguo io è semplice ed efficace. Parcheggio la mia macchina davanti alla stanza del motel. Scarico tutto quello che voglio tenere al sicuro con me, tipo mutande, IPad e venti centimetri di dolce al cioccolato per la colazione del giorno dopo. Vado in bagno, mi lavo i denti. Mi svesto, indosso una maglietta d’ordinanza e sono pronto per svenire sotto le coperte. Prima mi accerto che il condizionatore, di quelli vecchi e rumorosi, montato sotto la finestra della mia camera, sia effettivamente spento e non si metta a spararmi addosso aria fredda durante la notte. Inizio a perdere coscienza… Si… il sonno mi prendeee… Mmmm… stranoo… fatico a respirare… gli occhi sono di nuovo aperti. Cosa cazzo è questa puzza? Sembra gas di scarico. No, non può essere, sono sicuro che la finestra sia chiusa, sigillata ermeticamente. Appena arrivato, avevo lasciato la porta della mia stanza aperta per cinque minuti, giusto per ricambiare l’aria e contenere le paure da covid. Ma adesso è tutto chiuso. La puzza aumenta. Accendo la luce. Non credo sia fissazione, la mia. No, vedo proprio fumo. Mi alzo dal letto, apro la tenda. Chi è quel coglione che sta tenendo la sua macchina in moto davanti alla mia stanza? Ma guarda che nuvola di gas che sta alzando! Mi infilo di nuovo i jeans e una felpa. Esco. Busso alla portiera della macchina che sta inquinando più di un trattore in galleria. Un tizio solleva la testa e apre il finestrino. Gli faccio presente che sta ammorbando la mia stanza, che la sua marmitta è giusto davanti al filtro del mio condizionatore. Si scusa, spegne il motore. Rientro, dopo aver lasciato nuovamente la porta aperta, questa volta con un’urgenza ancora maggiore. Nonostante l’odore sia ancora intenso, provo ad addormentarmi di nuovo… Che c’è adesso? Ancora fumi di scarico? Com’è possibile? Guardo fuori dalla finestra. La macchina è di nuovo in moto, la nuvola ancora più grande. Merda.
“Brother, man, ho diritto di stare qui parcheggiato, anche la mia stanza è qui”, mi risponde lo stesso tizio di prima, quando gli dico che non può tenere il motore acceso e che sta rendendo irrespirabile la mia stanza. “Fatti dare un’altra camera”, aggiunge con un sorriso strafottente e con quell’accento tipico che si sente dappertutto nel sud. Che lui possa avere una stanza in questo pur modesto motel inizia a risultarmi impensabile, una balla grossa come il suo maledetto pick-up. Adesso non è più da solo, in macchina con lui c’è una ragazza. Se avete una stanza, perché ve ne state qui al freddo e non andate a trombare al caldo, è il mio primo pensiero. Nessuno dei due ha uno sguardo particolarmente acuto, ma non ho voglia di mettermi a fare altre discussioni, mi arrendo. I motel, qui in America, sono noti per essere luoghi in cui non puoi andare tanto per il sottile. Anche quando queste catene si rifanno la facciata e rinfrescano il loro logo, si tratta di posti dove non di rado circola umanità varia. Prostitute o spacciatori non sono proprio una sorpresa, mettiamola giù così. Il tizio del pick-up in questione non mi da l’idea d’essere pericoloso. Solo un idiota. Nonostante lo scherno, poi, nemmeno mi ha risposto con quel tono minaccioso che a volte quaggiù usano gli aspiranti gangster in miniatura quando pensano d’essere in qualche patetico video hip-hop.
E qui bisogna aprire una parentesi. Se però le magagne sociali non vi interessano, saltate il prossimo paragrafo.

[Anche se gli osservatori europei si appassionano solo alle rare sparatorie di massa, quelle dove è quasi sempre coinvolto un bianco con problemi mentali o di fanatismo religioso, quotidianamente i giornali locali americani sono pieni di notizie relative a banali discussioni e litigi che degenerano quando qualcuno tira fuori una pistola. E molto ma molto spesso, carnefici e vittime hanno la pelle decisamente più scura. L’episodio dell’omicidio in autostrada, è solo uno dei tanti esempi di violenza estrema scatenata da situazioni che si potevano davvero risolvere con un vaffanculo e un dito medio. Certo, si tratta anche in questo caso di episodi drammatici isolati, che avvengono in un Paese da oltre 330 milioni di persone. Ma si tratta di crimini decisamente più numerosi dei momenti di estrema pazzia che portano a riversare interi caricatori, disponibili a buon mercato, su decine di malcapitati di turno. Mentre la periodica sparatoria di massa arriva sugli schermi della CNN, letteralmente tantissimi altri omicidi e momenti di violenza insensata, che avvengono ogni santo giorno, non superano le singole cronache cittadine nei diversi Stati. Già solo nelle 24 ore precedenti la correzione dei refusi di questo paragrafo, per puro caso ho letto che a Chicago, la capitale suprema della violenza da armi da fuoco in America, un bambino di due anni è stato colpito due volte alla testa e adesso è in ospedale, in condizioni gravissime. Si trovava a bordo di un’auto coinvolta in un altro folle episodio di cosiddetta “road rage”, come quella di Lumberton. I conducenti di due macchine hanno litigato per chi avesse diritto a occupare una corsia, si sono inseguite per un po’ lungo una nota strada di Chicago, poi uno ha sparato all’indirizzo dell’altra macchina, come niente fosse. Miei cari idealisti, l’America del 2021, come quella del 2008 e del 2016 (ma si potrebbe andare in là nel tempo di altre annate elettorali chiave) non ha un problema d’armi d’assalto registrate a nome di squilibrati mentali ben noti nelle loro comunità. Ha invece un problema molto più grave e preoccupante per milioni di persone che vivono nei quartieri dove si verifica la stragrande maggioranza delle sparatorie. Un problema immenso di armi illegali nelle mani di migliaia di giovani e criminali disparati, spesso aderenti a gang e bande varie che fanno affari vendendo droga a migliaia di altri disgraziati. I regolamenti di conti e le vendette sono all’ordine del giorno, ma rimangono confinate nelle cronache locali, non arrivano sulle prime pagine dei quotidiani progressisti ossessionati dalla giustizia sociale a sfondo razziale e dagli eccessi violenti commessi dai poliziotti. La giustizia sociale si vende molto bene tra noi residenti del sopracitato Acela Corridor, mentre giriamo la testa dall’altra parte quando nei quartieri a due passi da casa nostra si sparano per il controllo di un isolato, o per un banale complimento ad una donna, e nel frattempo riescono pure a uccidere bambini innocenti o persone che finiscono casualmente nel mezzo (tutto vero e documentato più e più volte, pure in video che circolano sui siti dei principali canali televisivi, perché non è una rarità). Diciamo che quando vedi certe scene nella città dove vivi, conosci bene certe zone, e poi unisci un po’ di puntini vari, che si ripetono costantemente sempre e solo nello stesso modo un po’ ovunque in America, impari a stare lontano dalle grane. I video hip-hop saranno pure tanto alla moda, e così pure scimmiottare i comportamenti criminali degli autoproclamati gansta. Ma la realtà, miei cari, è molto più squallida. Non è la povertà a creare i problemi, ma il dollaro facile delle attività illecite (Ovviamente, abbiamo già pure casi dove le persone si sono uccise per chi avesse diritto o meno ai generosi sussidi federali distribuiti alle famiglie). Dopo anni di vita in America, inizi a pensare che sia già un miracolo che quaggiù i poliziotti non siano molto, ma molto più violenti, e che riescano spesso a mantenere almeno una parvenza d’ordine in quartieri dove regna l’anarchia e non esiste nemmeno una criminalità organizzata che faccia rispettare quei codici d’onore in grado di evitare il peggio per donne e bambini. Certo, se a New York vivi nel Village bohémienne, nemmeno avrai coscienza di questi problemi. Ma se vivi in una tranquilla zona residenziale di Brooklyn e decidi di mettere piede in quartieri limitrofi dove le mappe della polizia segnalano sistematicamente sparatorie che colpiscono innocenti a qualunque ora del giorno, ti domandi se non sia il caso di tornare sui tuoi passi. In quest’America ipocrita, che oggi decide pure d’abbandonare l’idealismo alla Martin Luther King, quello della cecità di fronte ai colori della pelle, per sposare invece la retorica politica delle mille identità, è una verità scomoda il colore di chi spara e l’identità razziale ed etnica delle vittime, ancor di più quando le brutali statistiche ufficiali prendono vita sotto forma di aneddoti e volti non più invisibili. Insomma, in questa pazza, adorabile, veramente libera, anarchica e fottuta America, dove comunque ci sono tante cose che funzionano bene e opportunità impensabili altrove, impari a farti i cazzi tuoi e insegni questa basilare regola di sopravvivenza animale ai tuoi figli. Eviti anche solo le rogne potenziali, perché diventi un esperto a riconoscerle, già solo quando sono appena delineate e si vedono giusto in trasparenza. Fanculo al tizio dell’inquinante pick-up].
Tra me e me auguro un decesso lentissimo e atroce ai due occupanti della ciminiera a quattro ruote. Vado alla reception. Sono appena le undici di sera, ma già da due ore l’addetto lavora dietro la protezione di un vetro, in un ufficio chiuso al pubblico. Anche lui non vuole rogne, e dice che può fare nulla con il tizio del motore acceso. Gli chiedo una nuova stanza e me la procura al volo. Si trova esattamente sopra la reception. Perfetta. Sposto le mie cose e vado finalmente a coricarmi. Se le mie maledizioni sono anche solo lontanamente efficaci come quelle di Alex Drastico, in North Carolina ci dovrebbero già essere due stronzi in meno. Ma conoscendo la ben nota legge che connette le continue gravidanze e il basso quoziente intellettivo dei nascituri, in assenza di terremoti demografici servirà ancora qualche decennio per sradicare una diffusissima cultura fatta di ignoranza e violenza che spesso non è nemmeno tanto subdola. Non si può avere fretta. Spiacente per le anime belle, che si auto-proclamano socialiste e che riescono a farsi eleggere al Congresso americano. Ma questa sottocultura ha niente a che vedere con la povertà, non è aggravata dalla recessione da Covid e simili. No. È pure in grado di abbattere le barriere di genere. Le adolescenti americane contemporanee, che sono passate da Whitney Houston a Cardi B, e si prendono a calci dentro i fast-food o nei centri commerciali, non arrivano da famiglie dove si fatica a mettere insieme il pranzo e la cena. Le donne che si tirano per i capelli e fanno a pugni all’imbarco di un volo per Atlanta, non hanno problemi particolari con le loro carte di credito. Crescono solo con modelli di famiglia dove troppo spesso gli uomini sono assenti, le maternità avvengono con frequenza in solitudine e le donne sono considerate oggetti da riproduzione e svago come neanche nel nostro meridione degli Anni Cinquanta. L’esistenza di questi valori e modelli comportamentali è un scomodo segreto di Pulcinella, che in tanti quaggiù fanno finta di dimenticare, esattamente come la verità sulla violenza delle armi da fuoco. Amen. Per me è tempo di fare la nanna e mettere a dormire le masturbazioni sociologiche (che avevo promesso di mettere tra parentesi, dannazione!!).
IL GIORNO DEL PREGIUDIZIO

Una buona notte di sonno risolve ogni cosa! Mi alzo di buon umore! La rabbia della sera precedente è scomparsa. Arrivo pure ad accettare serenamente che i due tizi del pick-up possano ancora non essere passati a miglior vita e siano invece sulla strada della loro sempre possibile redenzione. Anche la colazione mi sembra perfetta. Mi preparo il caffe con la macchinetta e le cialde offerte gentilmente da questa che è una delle catene di motel più deprimenti d’America. Addento con gusto il dolce al cioccolato che mi sono portato dietro da Brooklyn, e che già so mi terrà compagnia per giorni e giorni. Raccolgo tutte le mie cose e mi rimetto in macchina, non prima d’aver fatto rifornimento di caffè alla reception. Guardo il navigatore su Google. Non mente. Dice che davanti a me, prima d’arrivare a North Miami Beach, ho ancora la bellezza di 802 miglia. Che vuoi che siano 1290 chilometri. Sono le 8.30, andiamo.
Dopo nemmeno un’ora a guidare, ho già fame. Un po’ come quando ero bambino: bastava che uscissi di casa e subito supplicavo mia madre di comprarmi qualcosa da mangiare. Si, il brioscione al cioccolato della colazione in motel era buono. Ma non sarebbe meglio se adesso mi fermassi in quel ristorante scassatissimo che a fianco della mia stazione di servizio pubblicizza il miglior pollo fritto di tutto il sud? Non so nemmeno io come resisto alla tentazione. Il pollo fritto è uno dei piatti che definiscono la tradizione culinaria del meridione americano, esattamente come il barbecue, che quaggiù è una religione con innumerevoli chiese. Entrambi hanno nulla a che vedere con i loro omologhi europei. L’abitudine di friggere i pennuti, anche quelli che non riescono ad alzarsi in volo, è universale. Le commistioni culturali e l’adozione di usanze provenienti da Europa e Africa hanno creato nel tempo la via americana alla frittura del pollo. Nonostante quaggiù si ripeta come certezza assoluta che siano stati gli schiavi i primi a friggere il pollo, e per questo sia ora il piatto più sacro e comune tra i neri d’America, uno studioso afroamericano ha invece scoperto che le radici sono tutte e interamente scozzesi. Sono state le donne tenute in schiavitù nelle ricche famiglie bianche che hanno poi però perfezionato le ricette e le hanno tramandate nel tempo. Il ruolo degli scozzesi e dei britannici del nord nella creazione della più generale cultura del Sud americano è stato analizzato da altri storici e studiosi. Un economista come Thomas Sowell, per esempio, pure lui afroamericano, ha rintracciato nella lontana Scozia le radici di molti valori e atteggiamenti diffusi nel sud, una più generale attitudine verso comportamenti litigiosi e conflittuali, il temperamento focoso e aggressivo. Ha osservato le differenze con altre regioni degli Stati Uniti dove pure ci sono consistenti minoranze nere (ma di origine caraibica), ha visto come questi valori condivisi nel Sud da bianchi e neri abbiano superato le barriere razziali e, con le migrazioni degli afroamericani nel Nord (simili a quella di noi meridionali italiani nel Settentrione), si siano consolidati nelle periferie segregate delle grandi metropoli, aggravandone le disparità sociali. Se la pistola facile nelle discussioni animate è letteralmente considerato un problema sanitario cui le autorità americane non sanno come mettere mano, e l’America progressista punta sempre e solo il dito sulle presunte colpe della schiavitù (la spiegazione-prezzemolo), l’obesità da frittura è fortunatamente un problema meno drammatico nelle sue manifestazioni immediate, anche se dalle conseguenze sanitarie decisamente più vaste e durature per larghe fasce della popolazione.
Il pollo fritto, che adesso vorrei andasse a integrare anche la mia dieta mattutina, è un simbolo del Sud degli Stati Uniti come i fuochi d’artificio e la presenza di Dio in autostrada. Viaggiando per le Carolinas si trovano le insegne più gigantesche che ti invitano a comprare qualunque tipo di razzo pirotecnico. E in ogni dove si trovano cartelloni stradali che ti ricordano quanto tu sia un puntino minuscolo nell’Universo al cospetto del Padre Eterno (per chi ci crede, ovvio, e non per noi atei impenitenti). “Gli uomini saggi cercano Dio”, “Pentiti”, “Dio, perdona i miei peccati” sono solo alcuni dei messaggi più ripetuti. Di rado si può trovare qualche cartellone politico, come quello di Trump che mette in guardia dal socialismo o quello contro Lindsey Graham, il più noto senatore Repubblicano della South Carolina. Viaggiando lungo la I-95, anche i meno attenti alle sfumature sociali capirebbero che la religione occupa un ruolo fondamentale nel sud americano.

Quando viaggi in North Carolina, in direzione Florida, tra i cartelli più riconoscibili ci sono quelli di “South of the Border”, un’attrazione turistica che si trova a Dillon, in South Carolina, appena al di là del confine sud della Carolina del nord (da qui il nome). Le innumerevoli insegne lungo l’autostrada I-95, con tanto di segnalazione delle miglia mancanti per raggiungere la meta, sono forse anche più famose dell’attrazione in se. Nata negli Anni Cinquanta, si tratta di un’area che comprende ristoranti, un motel, una stazione di servizio, un minigolf, e delle giostre. Tutto in tema finto messicano kitsch. Anche prima della crisi portata dalle pandemia, la popolarità di questo luogo tra i frequentatori dell’autostrada era in calo costante. Per la sensibilità americana attuale in fatto di etnia e razza, gli stereotipi presenti al “South of the Border” non sono semplicemente pacchiani, sono invece quasi al limite del razzismo. La società americana sta lentamente provando a liberarsi di tutte le caricature e dei preconcetti a sfondo etnico e razziale, pur se alcuni sono considerati in qualche modo più innocenti degli altri. Viaggiare per oltre 2000 chilometri in due giorni è un potente promemoria sugli Stati Uniti, come il pippone di cui sopra sulle pistole e il pollo dovrebbe aver reso chiaro. Così, mi fermo ancora una volta al South of the Border, e faccio l’ennesima sosta dove seziono altre questioni sociologiche con la poderosa accetta che solo una Guida Inutile. Niente parentesi, ché proprio non ci riesco. Solo flusso di coscienza.
Siamo nell’America del 2021, quella che sta lavorando per andare su Marte. Eppure, ancora oggi, quaggiù ci sono alcunu cliché un po’ duri a morire. Così, nei suoi cartoni animati, da Curious George la scimmia a Garfield il gatto, mio figlio vedrà sempre e solo cuochi italiani che parlano inglese come immigrati dell’800. Più avanti scoprirà che quando non siamo cuochi, noi italiani siamo spesso mafiosi e conserviamo la tradizione di seppellire i nostri nemici nelle discariche, dopo averli sezionati nel retro di qualche macelleria in New Jersey (e qui, purtroppo, c’è anche un pizzico di verità, che va oltre la finzione cinematografica e lo stereotipo più trito, o tritato, visto che parliamo di macellai). Un’altra delle convinzioni più radicate nell’America odierna è che tutti gli asiatici siano intelligenti, oltre al fatto che siano tutti uguali: poco importa se arrivano dalla Cina, dalla Corea o da almeno un’altra mezza dozzina di nazioni, tra le quali possiamo metterci pure l’India. Un pregiudizio positivo, per quanto positivo, non fa meno danni di uno stereotipo negativo. E può scatenare tensioni razziali che in paesi come l’Italia sono impensabili solo perché l’Italia, diversamente da quello che tanti nostri connazionali credono in buona fede, non è una società multietnica nemmeno alla lontana. Anche in una sperduta cittadina di qualche centinaio di abitanti nel bel mezzo del Kansas più rurale potrai trovare una trattoria coreana o messicana. Ogni statistica americana in tema d’educazione racconta sempre la stessa cosa: gli asiatici ottengono risultati migliori rispetto a tutte le altre categorie demografiche di studenti, siano essi divisi per etnia o razza. Hanno un’etica del lavoro molto radicata, che applicano anche nello studio, e reti di supporto familiare ampie, dove gli anziani sono ancora parte integrante del principale nucleo su cui si fonda ogni società. Gli studenti di origine asiatica sono migliori dei bianchi, dei neri e degli ispanici (anche a parità di redditi). A New York ci sono pressioni politiche fortissime per eliminare i test di ingresso nelle scuole superiori, perché gli asiatici, pur essendo una minoranza relativa in città, li superano con risultati che sono una spanna avanti a tutti. No, non sto esagerando, fidatevi.
Quando accadono fatti violenti che coinvolgono gli asiatici, come i recenti omicidi di Atlanta ad opera di un giovane ragazzo bianco ossessionato dal sesso e dalla religione, a New York uno degli esponenti afroamericani più influenti di tutta America, il reverendo Al Sharpton, deve dire a chiare lettere che si aspetta anche dalla vasta comunità nera newyorchese una condanna senza riserve di simili crimini dettati da odio etnico. Perché in una società dove la diversità culturale è ovunque, i conflitti etnici e razziali, così come i pregiudizi, sono trasversali a tutte le componenti demografiche. È un tutti contro tutti. Alle discriminazioni sociali, e alle violenze talora vissute per mano delle forze dell’ordine dagli afroamericani, per esempio, fanno da contraltare le discriminazioni e le violenze non provocate che questi ultimi riservano agli ebrei ortodossi o agli asiatici. Da settimane nelle grandi città americane si registrano episodi di odio e violenza a sfondo razziale, e in troppi casi gli aggressori sono afroamericani. Si tratta di semplificazioni estreme, non cercate in questa sede argomenti sofisticati. Quest è un blog dove offro solo il mio punto di vista, limitatissimo e opinabile. Quelli che gli americani chiamerebbero “i miei due centesimi”. Nessuno potrebbe onestamente quantificare quanti americani siano oggetto di discriminazione e quanti altri, invece, pratichino la discriminazione. Servono tanta pazienza e tanto tempo per far sparire le aberrazioni nelle società davvero complesse e multiculturali come quella americana. E bisogna pure avere il coraggio e l’onestà intellettuale per accettare comunque la presenza di livelli minimi e imprescindibili di intolleranza, razzismo e pregiudizi vari. Ma in America, nella sua società agitata, ansiosa, aggressiva e paranoica, i miglioramenti si vedono, sono tangibili. Quaggiù si discute della qualunque, anche animatamente e con odio reciproco niente affatto celato. Molto, molto più che in Italia.
Tanti dei miei amici italiani, persone speciali, che si considerano giustamente dalla mentalità aperta e progressista, in America sarebbero altrettanto giustamente considerati dei razzisti. Perché in Italia cresciamo imbevuti di pregiudizi e stereotipi, amplificati da una cultura nazionale che glorifica il passato e santifica anche la più banale pastasciutta, creando eresie dal nulla di un semplice punto vista. Questa non è la sede per una discussione che è ancora più complicata di quel che noi italiani ingenuamente pensiamo, magari quando parliamo di ius soli e dei boo-boo negli stadi (quelle robe lì, l’America, le ha viste negli Anni Cinquanta). Non basta dire che siamo tutti uguali e poi, per esempio, fare battute del cazzo sulle tradizioni altrui. “Eh, ma dai! Che esagerazione! È solo uno scherzo”. No, miei cari. Magari è uno scherzo in Italia, e gli italiani ancora lo accettano. Ma non quaggiù. Un esempio concreto può aiutare a capire un minimo. Qualche settimana fa, a proposito delle nomine per gli Oscar, l’Hollywood Reporter se ne è uscito con un titolo che recitava: “gli attori asiatici rompono il soffitto di bamboo”. Apriti cielo. Quando in America si usa l’immagine del “glass ceiling” (soffitto di vetro) si fa riferimento a tutte quelle barriere invisibili che impediscono a determinate categorie demografiche di progredire nella scala sociale. Chi ha scritto quel titolo ha preso in prestito uno degli stereotipi più banali possibili. Che però, nel 2021 americano, è considerato giustamente ridicolizzante e un pure un bel po’ offensivo. Dico giustamente solo per esprimere il fatto che anch’io, adesso, lo giudico offensivo. Quando sono arrivato in America, non ci avrei nemmeno fatto caso, e forse lo avrei usato senza pensarci su due volte. Come avrei continuato a fare battute sull’aspetto fisico delle persone, o sul loro modo di parlare (che noi italiani facciamo in continuazione). Adesso lo trovo irritante, come considero urticanti e offensivi gli stereotipi che ancora oggi, nella cultura popolare, rappresentano gli afroamericani come pigri, tanto per continuare con gli esempi. Quando arrivo a North Miami Beach, letteralmente tutti i miei vicini di casa, in un isolato dove noi siamo l’unica famiglia di bianchi, potrebbero smontare il pregiudizio in meno di un minuto: dal tassista che non ha limiti d’orario al camionista che trascorre le notti guidando in autostrada, passando per la giovane insegnante che fa straordinari non pagati, l’impiegata che la sera va a lavorare nel ristorante o la mamma che, dopo aver cresciuto i propri figli, si è buttata senza pensarci un attimo nel doppio affidamento. Dovremmo lavarci la bocca, prima di parlare a loro di pigrizia.
Ci sono stereotipi che di primo acchito risultano odiosi, come quelli che vedono gli uomini bianchi e le donne nere sempre perennemente arrabbiati; oppure quelli che considerano meno “neri” caratterialmente gli afroamericani nati da coppie miste, o che abbiano un patrimonio genetico frutto di intrecci persi nei secoli. Altri pregiudizi fanno in qualche modo sorridere tanti americani, tipo quello che dice che i bianchi non abbiano senso del ritmo (nel mio caso, la Ragazza Dai Capelli Rossi, dice che è vero, ma dimentica che lei componeva musica per grandi orchestre jazz). Oppure sembrano preconcetti innocui, come quello per il quale tutti i neri sappiano giocare a pallacanestro o i nativi americani amino solo scommettere. Sappiamo che in ogni pregiudizio c’è sempre un legame con qualche aspetto minimo di verità, che può riguardare anche una minoranza consistente di persone. Ma i pregiudizi sono soprattutto la base di incomprensioni ed odii che possono sopravvivere a lungo. Per questo li combattiamo con un’energia che sembra fin eccessiva e degna di migliori cause. Per questo in America si sta via via affermando una sensibilità che condanna anche i pregiudizi apparentemente meno problematici. Quello che era consentito dieci anni fa, oggi non lo è più. L’immagine del “bamboo ceiling” usata dall’Hollywood Reporter venne fuori esattamente dieci anni fa. “Breaking the bamboo ceiling” fu il titolo di un libro che offriva agli asiatici americani consigli per progredire professionalmente nel mondo delle grandi aziende. L’autrice era una consulente di carriera di origini coreane. Oggi quella stessa espressione ha toccato nervi scoperti, proprio a dimostrazione che le sensibilità cambiano e che non dovremmo mai dare nulla per scontato e immodificabile. Fatevela come meglio credete. Ma, per favore, accettate la carbonara di chi vuole il bacon, e pure la panna. Senza scassare la minchia.
MUSICA PER I TUOI OCCHI

Bene. Tutta questa divagazione è nata per aver avuto ancora una volta la brillante idea di fermarmi 20 minuti a South of the Border. Mentre scrivo al presente questa sorta di diario postumo di un viaggio avvenuto a inizio marzo, il “border” per eccellenza, quello tra Texas e Messico, è di nuovo al centro di una crisi, con migliaia di immigrati centroamericani che sperano di poter entrare in America, convinti che Biden li accoglierà a braccia aperte. Per il momento sono accolti negli stessi centri di detenzione in cui li metteva Trump, che a sua volta usava i centri creati da… Obama. La stampa americana, dopo aver parteggiato senza un minimo di pudore nei 4 anni di campagna elettorale per cambiare l’inquilino della Casa Bianca, adesso sembra avere un sussulto di dignità. Associated Press riconosce che si tratta di una vera crisi, più grande di quelle vissute dall’Amministrazione precedente. E che Trump, almeno, aveva la decenza di far entrare i giornalisti nei centri di detenzione, mentre Biden sta cercando di nascondere il tutto dalla vista dell’opinione pubblica americana. Quale sorpresa… Anche i paladini della giustizia globale, come la famosa deputata newyorchese Alexandra Ocasio Cortez, che non esitavano un momento a parlare di campi di concentramento sotto la Presidenza di Trump, da settimane sono zitti. Magari cambieranno idea, vedremo. Per ora, a cambiare tono, è quella stampa prezzolata che sta facendo i conti con un brutale risveglio: Donald Trump, con la sua faccia tosta faceva vendere copie, alzava gli indici di ascolto e spingeva a cliccare qualunque pagina su internet. Adesso, con Biden che non si azzarda ad andare in sala stampa se non ogni morte di papa, e inciampa a ripetizione sulla scaletta di Air Force One, sono dolori per chi deve vendere un prodotto giornalistico che sempre meno americani sono disposti a comprare… Nel frattempo, Trump è nel suo buen retiro a Mar-A-Lago. Meglio non confidare troppo che sia cotto al sole di Palm Beach.
Se non fosse per South of the Border, non sarebbe visibile una grande differenza tra North e South Carolina, geograficamente parlando e limitandosi al paesaggio della I-95. Ma la più meridionale delle due Caroline è di sicuro meno avanzata economicamente. Così come non ho avuto tempo ed energie per fare una deviazione nella sempre piacevole Raleigh, adesso ho ancora meno forza per deviare verso Charleston. Insieme a Savannah, in Georgia, si tratta di una delle tante chicche del sud degli Stati Uniti. Quando quaggiù si parla di ospitalità e charme, Charleston e Savannah vengono subito alla mente. Entrambe le città sono state centri portuali importanti nella tratta degli schiavi. Le piantagioni di cotone hanno creato una ricchezza immensa, tra le più grandi di tutte le tredici colonie originarie. Il riflesso di quel periodo storico è ovunque nell’architettura del centro di Charleston, una delle città più visitate d’America. Ma io devo davvero tirare dritto.

Faccio parecchie soste brevi. Continuo a ripetere tra me e me che devo assolutamente arrivare a Miami prima della fine della giornata. Mangio lo stretto necessario, senza esagerare, per non appesantire le palpebre. Alle due e mezza del pomeriggio intravedo finalmente il cartello che dice “Welcome to Georgia”. Dalla South Carolina famosa per le arachidi, che nelle stazioni di servizio vengono servite in una tradizionale zuppa calda, entro nello Stato che deve la sua fama americana alle pesche, e il cui nomignolo è proprio “The Peach State”. Continua a piovere, tanto per non farmi mancare tutto quello che può rendere ancora più lungo il viaggio. Ma almeno, adesso, la mia autostrada preferita torna ad avere tre corsie per senso di marcia. Tutti iniziamo a spingere sull’acceleratore, come se non vi fosse più un domani. Da ore ho una mano sul volante e l’altra sulla radio. Detta così, non ispira molta confidenza in tema di sicurezza stradale, lo capisco.
Ho con me alcuni cd, ma ho scoperto che la mia musica mi fa addormentare. Non la scelta specifica fatta prima di partire, ché ho portato dietro con me solo cose che adoro. Potrei ascoltare i dischi di Tame Impala all’infinito. E anche sul telefono, che posso facilmente connettere all’impianto stereo di questa Honda Civic ormai un po’ avanti negli anni, ed ereditata dalla buonanima di mio suocero, c’è tutta la musica che mi mette di buon umore. Posso passare senza soluzione di continuità da General Public a Beastie Boys, dal più commerciale Nusrat Fateh Ali Khan al più romantico Paul Weller, da Madonna a David Morales, passando per B-52’s e Bushwacka. Il punto è che quando sei in macchina da solo per ore, la musica che non si interrompe mai è peggio dell’ipnosi. Se stai guidando nel mezzo del traffico veloce e selvaggio di una tangenziale, nemmeno ci pensi. Sei tutto bello e concentrato sul guardrail alla tua sinistra e su quell’autotreno che potrebbe ucciderti solo con un’accenno di sterzata. Ma se vai ad andatura regolare, su una strada dritta all’infinito, di quelle che capisci perché c’è un futuro per le macchine che si guidano da sole mentre tu ti fai una pennica; ecco, in questo caso, tra una canzone e l’altra, ti prendono desideri improvvisi, di cui mai avevi sospettato l’esistenza, e vuoi sapere dove poter acquistare diamanti, materassi e i servizi di un avvocato che spacca il fondoschiena alla tua assicurazione dopo che tu ti sei schiantato fuori strada perché avevi le mani sull’autoradio.
La pubblicità non è solo l’anima del commercio, è un vero e proprio salvavita quando viaggi in solitaria. Certo, ci sono anche cose più interessanti, come i podcast infarciti da trenta minuti di pubblicità. Ma devi avere la pazienza e la voglia di scaricarteli prima di partire. NPR, la radio pubblica americana, si prende ovunque e offre una perfetta alternativa ai programmi pre-registrati che vanno tanto di moda oggi nelle cuffie. E poi, oltre a notizie ed approfondimenti nazionali e internazionali, è ancorata a stazioni radiofoniche locali, che ti aggiornano su ogni ingorgo possibile. Quando anche NPR ti viene a noia, e ti trovi dalla Virginia in giù, hai poi l’imbarazzo della scelta tra decine di stazioni che programmano un solo tipo di musica: country. Non quella che noi italiani immaginiamo che sia, come un americano potrebbe immaginare che noi italiani ascoltiamo solo le musiche tradizionali che quaggiù accompagnano ogni fiera a base di salsicce e cannoli. La musica country è un fenomeno che si è evoluto nei decenni, esattamente come il rhythm and blues o il rock. Chi pensasse ad armonica e banjo rimarrebbe deluso. Adesso parliamo di chitarra, basso e talvolta pure batteria. Se anche molti italiani possono riconoscere i vecchi nomi di Johnny Cash e Dolly Parton, tanti altri come i più contemporanei Blake Shelton e Brad Paisley non superano l’Atlantico. Ma quaggiù sono popolarissimi, conosciuti attraverso show musicali o pubblicità televisive. Poco meno di un decimo di tutta la musica venduta negli Stati Uniti è musica country. Tenuto conto delle sue origini condivise con la musica folk, non si può trovare un paragone simile in Italia. Ma poiché si tratta spesso di ballate a sfondo romantico, direi che il raffronto più comune in termine di popolarità potrebbe essere quello con le canzoni melodiche sanremesi (anche se quel tipo di musica, qui in America, si chiama Adult Contemporary). Dopo un po’, io e la musica country facciamo fatica a convivere. Così ho bisogno di tornare al punto di partenza del mio lungo viaggio, e mi metto a cercare nervosamente qualunque stazione che abbia solo musica Anni Ottanta. Sto scoprendo che la mia Honda è più una macchina del tempo che una banale automobile nel senso classico del termine. Paul Young, Cyndi Lauper, Wham e Bonnie Tyler stanno riportando alla memoria anche le cotte liceali di cui avevo perso completamente traccia.
IL SOL DELL’IMBRUNIRE
La I-95 taglia la Georgia nel suo punto più stretto. Tradotto, in un paio d’ore vedo finalmente il cartello della mia meta finale: Welcome to Florida, il Sunshine State. Nonostante la promessa di una rete wifi aperta, non mi fermo al centro di benvenuto per turisti e tiro avanti ancora per un po’. Come già il giorno prima a Richmond, e come già detto più sopra, l’attraversamento di Jacksonville offre la solita discreta carica d’adrenalina, per il traffico e le velocità sostenute rispetto agli irrisori limiti che nessuno rispetta. Insieme a Miami, Orlando e Tampa, è una delle quattro grandi città di questo Stato altrettanto grande, che con oltre 21 milioni e mezzo di abitanti è il terzo in America per popolazione, davanti allo Stato che dà il titolo a questa Guida Inutile. Dal confine con la Georgia alla mia destinazione a North Miami Beach ci sono ancora almeno 600 chilometri. Adesso, dopo un giorno e mezzo passato con le chiappe attaccate al sedile, mi sembra poca roba. Ma è quasi come andare da Roma a Torino, la qualcosa facevo spesso in passato. Quando partivo nel pomeriggio da Anzio, però, spesso facevo una sosta notturna a Piombino. E non solo per la pizza “Monarca” da Tonino. Nostalgia, non lo nascondo.
Alle cinque del pomeriggio sono stanco, e mi fermo presso l’area di sosta poco a sud di St. Augustine, quella che è la città più vecchia fondata dagli europei negli Stati Uniti. Gli esploratori crearono l’insediamento nel 1565 e da quell’epoca è sempre stato ininterrottamente abitato. Come già a proposito di Charleston e Savannah, anche la deviazione a St. Augustine varrebbe la pena (a poterla fare). Ma io devo proseguire e mi sono messo in testa che devo passare la notte in un letto conosciuto, possibilmente senza gas di scarico. Perdo il conto delle volte che mi fermo, con una scusa qualunque. Ho imparato tanti anni fa che quando sei stanco al volante, c’è una sola cosa intelligente da fare: fermarsi. Ancora ricordo un colpo di sonno all’angolo con la strada dove abitavano i miei genitori. Ero, letteralmente, a meno di 50 metri da casa e ho perso coscienza per uno di quegli istanti che poi ricordi in eterno. Poiché io, sempre nella mia vita torinese anni fa, sono riuscito anche ad addormentarmi in piedi, al concerto di un gruppo punk francese all’asilo occupato El Paso, l’ultimo dei miei desideri è schiantarmi fuori strada per un colpo di sonno. E se questo significa allungare a dismisura il mio viaggio, alleggerendolo pure con periodiche pennichelle manco fossi Leonardo Da Vinci, tant’è.
Quando ricevo il messaggio di Luca, l’orologio segna le 9 e quaranta e mi sto rilassando in un’area di sosta poco distante da Melbourne. Ho davanti a me ancora 150 miglia prima d’arrivare a North Miami Beach. In teoria, attorno alle undici potrei essere a destinazione. Ma non mi faccio illusioni. Sento la stanchezza, già so che dovrò fare stop almeno un’altra volta. Mi rimetto in viaggio nella notte e verso le undici vedo il cartello che indica la città di “Jupiter”, ché Giove è lontano anche in Florida. Urlo uno yeah comunque contenuto. Significa che sto entrando geograficamente nella lunghissima area metropolitana che comprende West Palm Beach, Fort Lauderdale e Miami. Se dovessi andare all’estremo sud di questa interminabile distesa urbana, dove non esiste soluzione di continuità tra case, centri commerciali e autostrade, mi dovrei fare qualcosa come 220 chilometri. Sono fortunato, invece, perché a me ne toccano cento di meno. Yeah…

Jupiter è sempre aria di casa. E magari un giorno mi compro la gigantesca villa dove adesso vive invece Tiger Woods. Non è tanto quel cartello a dirmi ogni volta che basta solo un ultimo sforzo per essere davvero a casa. È la strada che si allarga improvvisamente a cinque corsie, e poi il traffico che diventa poco alla volta più caotico. In una notte d’inizio settimana, a marzo, e ancora in tempo di pandemia epocale, non trovo certo gli ingorghi che sono invece la regola da mattino a pomeriggio. Ma l’illuminazione ininterrotta che divide le due carreggiate, e poi le macchine che sfrecciano come neanche sulla pista di Daytona, contribuiscono a tenermi sveglio e a darmi quella sensazione di luogo familiare. Anni fa provavo lo stesso tipo di sensazione quando la sera tardi arrivavo nell’area di Roma e proseguivo verso la Pontina. Adesso, da dieci anni a questa parte, è la South Florida ad essere diventata la mia seconda casa. Amici e conoscenti pensano che sia esotico vivere a New York e andare spesso a Miami. La stragrande maggioranza, quando sente la parola Miami, immagina solo spiagge o cocktail. I secondi non li vedo, le prime sono luoghi quasi ignoti agli autoctoni, come potrebbero essere le spiagge per un savonese medio. Ma io, in mezzo a questo continuo avanti e indietro che sempre ben poco ha avuto di vacanza, sono riuscito finalmente a capire l’amico Vittorio: ha trascorso una vita in aereo per lavoro, tra Londra e il Brasile, e lo trovava noioso quanto fare il pendolare su un treno tra Asti e Torino o interminabile come l’ora di punta sulla metro di Milano. Noi lo invidiavamo solo per ignoranza e perché confondevamo la realtà con una commedia di Natale.
MIAMI, PER NOI CHE SIAMO GENTE DI NEW YORK

Mi ero ripromesso d’arrivare a North Miami Beach alla fine della giornata, e non ci sono riuscito. Quando parcheggio davanti casa è mezzanotte già da sette minuti. Ho fallito nella mia impresa, ma sono contento ed esausto. Ho in corpo quella stanchezza che richiederà almeno altre due ore prima di riuscire a prendere sonno. Ho un piano ben preciso per i prossimi giorni, ma non so quanti giorni richiederà esattamente. Quando mi sveglio, metà mattinata è già passata. Per anni sono stato un animale sociale, sempre a mio agio con gli altri e circondato sempre da un sacco di persone (people person, diremmo quaggiù). Poi ho imparato a vivere in solitudine, e ad apprezzare solo la mia presenza. Adesso stare da solo in questa grande casa mi mette un po’ di malinconia. So che è una delle ultime volte che ci verrò, che per la mia famiglia un ciclo si sta per chiudere e non sappiamo ancora se ne riapriremo un altro, qui a Miami. Nonostante debba scavare tra scatoloni, dividerne il contenuto tra altri scatoloni, e poi impacchettare quadri e fotografie, cerco ogni occasione possibile per uscire di casa. Andare a comprare nuovi scatoloni mi sembra quella giusta. Non mi lamento quando mi tocca di tornare da Home Depot, per aggiungere carta e nastro da pacchi. Va bene pure se mi dimentico la carta da imballaggio, quella con le bolle, tanto sono di nuovo solo altri cinque minuti di macchina.
A salvarmi dalla possibile depressione serale ci ha pensato Luca, sempre lui. Superbo il ceviche a Miami Beach, con tanto di memorie dei nostri anni al liceo e infinite domande su come diavolo sia finito lui qui in America e, soprattutto, a Miami. Bella la sera successiva la cena a casa sua, dove il suo ufficio da ingegnere che smanetta programmi gestionali per aziende assomiglia molto di più a una saletta dei Criteria, gli epici studi di registrazione dei Bee Gees ed Eric Clapton, che due anni fa ho avuto la fortuna di visitare a North Miami. Ottima anche la cena al ristorante italiano, soprattutto perché anche in questo caso abbiamo avuto la compagnia della sua dolce metà, chiamata a rendere più gentile la nostra maschia rimpatriata. Se anche non mi traferirò a breve a Miami, sarò comunque sempre riconoscente a Luca per aver reso più leggere le mie giornate da orso nella caverna.

Nonostante il “miamian” medio non sappia davvero cosa sia la spiaggia, lasciandola ai poveracci che non hanno la piscina o ai turisti che si ammazzano tra i bar di South Beach, ogni volta che vengo a Miami io trovo sempre il tempo per andare almeno un’ora ad Haulover Beach. Sono i cinque dollari meglio spesi in assoluto, anche se io vado nel tratto di spiaggia aperto ai cani e non in quello dei nudisti. Agli inizi di marzo l’acqua è ancora gelida, ma in venti giorni, quando tornerò con il resto della famiglia per la chiusura definitiva della casa, fare il bagno sarà meno traumatico: acqua solo fredda, come a Coney Island a fine luglio. Quando non riesco ad andare ad Haulover, ma voglio almeno vedere il mare, vado a parcheggiare in un affollatissimo centro commerciale a Sunny Isles e da lì raggiungo la spiaggia dall’ingresso più vicino. Da quando ho lasciato Torino, con le sue colline e le montagne a due passi, adesso è l’acqua a rappresentare la mia idea principale di natura. Se vivessi a Miami, che pure riesce ad essere verdissima anche nel suo centro finanziario saturo di grattacieli, farei carte false per andare anche solo dieci minuti in spiaggia a vedere il mare. Vivere su una collina di Brooklyn, con il grande Prospect Park a un quarto d’ora, e con la vista degli alberi in quell’immenso parco che è invece il Cimitero di Green-Wood, non mi basta. Già quando vivevo a Bay Ridge non perdevo occasione per andare a camminare su Shore Road, e da lì al pier di 69th Street, per entrare in qualche modo fisicamente dentro la baia di New York. Adesso vado spesso al Brooklyn Bridge Park o anche solo a Red Hook. Nemmeno faccio più caso alla punta di Manhattan, che per me è solo uno sfondo per l’acqua tutto intorno. Poco importa se è torpida e puzzolente. Con questo metro di paragone, anche le alghe di Miami sono parte del paradiso.
EPILOGO
Continuo a impacchettare. Ho Spotify a tutto volume, potrei sentire a malapena la suoneria del mio telefono. Sono lentissimo e penso al mazzo che si faceva Christo per le sue opere d’arte. Non mi posso lamentare, le mie son più piccine e posso stare pure seduto mentre lavoro. Penso e ripenso. Rimpiango di non aver scritto una “Guida Inutile Miami” prima della pandemia. Ho iniziato a rinviare, mi dicevo che avrei aspettato di poter mettere insieme altre fotografie e informazioni, che non fossero solo quelle di Wynwood, Little Haiti, Design District o Miami Beach, inevitabili anche per chi, come il sottoscritto, vorrebbe invece soprattutto raccontare le città vissute quotidianamente da chi si muove tra casa e luogo di lavoro. Adesso so che le mie trasferte a Miami non saranno più così frequenti, magari solo una volta all’anno, chissà. Non temere, magica città, non mi dimenticherò di te, e prima o poi ti onorerò pure io, con quanto di più inutile riuscirò a mettere insieme.
Mi preparo, invece, a fare una trasferta giornaliera a Jacksonville e poi nei pressi di St. Augustine, per andare a consegnare alcuni degli scatoloni che tanto mi stanno appassionando. Almeno altri 1200 chilometri tra andata e ritorno a NMB, spalmati come minimo tra mezzogiorno e mezzanotte. Tanto per tenermi in allenamento prima del giorno in cui ripartirò da Miami per Brooklyn. Al mio rientro a New York avrò sulle spalle qualcosa come oltre 5400 chilometri in 11 giorni. E, una volta a Brooklyn, non avrò nemmeno il piacere d’andare dritto a casa. Son pur sempre tempi di merda, meglio fare un test per escludere di portare il covid con me. A Miami non lo so ancora, ma il mio vaccino arriverà prima del previsto e sarà il perfetto regalo anticipato per il mio cinquantaduesimo compleanno (ne ho scritto qui). Non mi sento vecchio, affatto. È il mio fisico, che ride, e prende per i fondelli le mie illusioni sulla presunta energia del ragazzino, nascosta da qualche decennio di sovrappeso. Dice, il mio fisico, che non ci sono trucchi e magie che tengano, nemmeno in questa che si fa davvero chiamare Magic City. Amen.
Arrivederci, Miami. Tienimi in caldo la spiaggia, come solo tu sai fare.