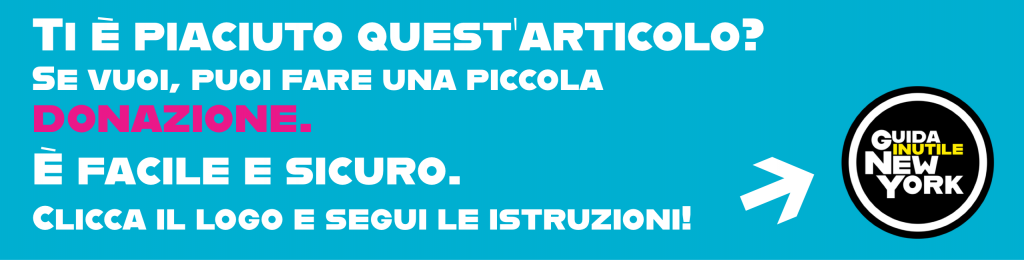Gente di New York #12 – Elvin che poteva essere Elvis
Quando decidi di seguire a piedi un furgone di UPS, e l’autista non ti prende per matto o per un ladro.
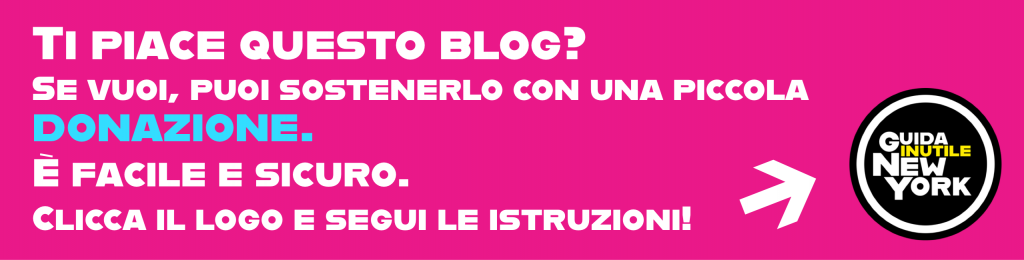
“Maranello! La prima cosa che voglio fare quando andrò in Italia è visitare Maranello”.
Elvin, in verità, dice Marinello, ma io capisco ugualmente di cosa sta parlando con tanta passione.
“Voglio vedere l’eccellenza artigianale in fatto di macchine”, mi spiega. E intanto afferra il mio braccio per evitare che automobili meno celebrate di una Ferrari, sfrecciando su Bond Street, possano stirarmi mentre io e lui ce la raccontiamo a bordo strada.
Ha ragione, Elvin. Laggiù, in terra emiliana, sanno davvero come costruire un’automobile nei minimi dettagli, e una vocale diversa non fa tutta questa differenza. Nel suo caso, invece, una banale consonante avrebbe potuto farla per sempre. Lo so perché qualche minuto prima ho deciso di non farmi i cazzi miei.

È afosa e bollente, quest’estate newyorchese, come quasi sempre in un qualunque pomeriggio di metà luglio. In giornate dove il termometro prova a sfiorare i 30°, quando hai un po’ di tempo libero per ciondolare senza scopo, e vuoi cercare sollievo dalla calura, la miglior alternativa all’ammollo nell’acqua torbida della sempre amata Coney Island è andare in un parco. Chi scrive autorevoli guide turistiche dedicate a questa selvaggia e zozza città che è New York, ripete come un mantra che non vi sia niente di meglio che dirottarsi a Central Park. È il parco propinato come il prezzemolo a tutti coloro che arrivano per la prima volta in città. Anche se magari si trovano all’antipode meridionale di Manhattan e devono scarpinare dai 5 agli 8 chilometri per raggiungere l’entrata su 59th Street; oppure, sempre per arrivare al famoso parco centrale, sono obbligati a scendere tra i miasmi di una stazione della metropolitana, dove sorretti da folate di aria vulcanica attenderanno l’arrivo della loro carrozza refrigerata in direzione Uptown.
Io, a Brooklyn, potrei comodamente sfruttare il piccolo gemello Prospect Park, che è pure dotato di una vasta area boschiva nell’ombra più totale, con tanto di piccole gole e cascate. Ma ho da sempre, sin dai miei nostalgici tempi torinesi, l’infatuazione per tutto quello che ricorda le fabbriche, i porti, i capannoni, le ciminiere. E nelle zone industriali, in genere, gli alberi scarseggiano. Qui a Gowanus, nella Venezia di Brooklyn dove ho incontrato Elvin, la regola non trova eccezione.
A dirla tutta, non sono proprio a zonzo o in completa libera uscita. Ho parcheggiato la mia macchina poco distante e sto solo aspettando che il resto della famiglia finisca la visita periodica dal dentista. Con passo lento, faccio avanti e indietro tra i ponti del canale che dà il nome al quartiere. Dopo un po’ di questo strascicato andirivieni, mi fermo su un marciapiede di Carroll Street, appoggiato ad un muro per sfruttare la scarsa ombra disponibile. Il vicino ponte levatoio è chiuso per lavori. Si tratta, peraltro, di uno dei rari esempi, qui in America, di ponte che scorre in orizzontale per lasciar passare le chiatte sul canale sottostante.
Mentre sono lì a cincischiare con il telefonino, tanto per far scorrere altri minuti, con la coda dell’occhio vedo arrivare sulla mia destra un uomo con un carrello porta pacchi.
“Ehi, how you doin’?”, gli dico.
L’uomo ricambia il mio saluto e iniziamo a parlare come fanno i veri newyorchesi. Cioè: nessuno di noi smette di fare quel che stava facendo. Lui continua a tirare dritto per la sua strada e insieme alziamo via via il tono della nostre voci, per farci sentire mentre la distanza tra noi aumenta. Nel resto d’America, e forse nel resto del Mondo, questa cosa sarebbe considerata scortese: perché o ti fermi a parlare, cercando un implicito via libera dall’altra persona, oppure non importuni uno sconosciuto, tantomeno se sta lavorando e non ha tempo da perdere. Ma qui a New York è assolutamente normale rivolgere la parola a qualcuno e poi tirare dritto come niente fosse. Ho perso il conto delle persone alle quali ho detto che avevano una bella maglietta o una giacca che invidiavo, e poi mi sono immediatamente smaterializzato dalla loro vista..

“Fa caldo, eh, oggi? Ma a me piace, sono nato ai Caraibi!”, mi dice mentre ha già attraversato la strada e raggiunto l’angolo opposto, proprio quello sotto il sole cocente di metà giornata.
“Per me è diverso!”, gli urlo. “Sono nato e cresciuto nel nord dell’Italia”.
“Aaah… ti capisco, man. Lassù fa più fresco, eh?”.
Ci scambiamo il “take care” d’ordinanza a queste latitudini, e torniamo ai nostri affari. Lo guardo mentre si allontana e raggiunge il suo furgone. Lavora per UPS, e lo avevo già intuito perché avevo riconosciuto la caratteristica divisa marrone che indossano lui e i suoi colleghi. Rimango per un po’ a rimuginare mentre osservo la scena. Penso che forse dovrei raggiungerlo, e scambiare altre due chiacchiere, prima di lasciarlo al suo lavoro. Mentre son lì che penso e ripenso (“no, dai, che faccio… ma posso mica andargli a rompere le palle, e poi sembrerei pure ancora più strano di quel che gli altri già pensano… però poi mi pentirei, a volte puoi incontrare persone speciali per pure caso e… oh, magari pensa che sia una checca* e che ci stia provando…”), il furgone parte. Ecco, lo sapevo.
* [Per favore, che nessuno si senta offeso se ho scritto “checca”. Sono un ultra-50enne venuto su senza troppa fatica in Italia, con tutta la mia bella dose di pregiudizi di cui sono ben consapevole. Come dico adesso anche ai miei amici e conoscenti americani: sono abbastanza vecchio e abbastanza italiano per fottermene allegramente del politicamente corretto e di tutto il ciarpame ideologico “woke” che da anni, qui negli Stati Uniti, sta asfissiando ogni conversazione pubblica, riducendo ad una farsa il diritto di esprimere un’opinione che non si allinei alla propaganda dominante. Potrei fingere di non essere imbevuto di cultura maschilista, sessista, razzista. Ma chi dovrei prendere in giro? Ma per piacere… Vengo da un Paese dove il concetto di altro e diverso è inculcato come anomalo sin dalla culla. Rompiamo i coglioni al prossimo se non fa cuocere la pasta al dente, se indossa i calzini bianchi, o se esce il cane facendolo cagare sui congiuntivi. Certo, potrei evitare di scrivere “checca”, o fare battute dicendo “ricchione”. Diventerei improvvisamente migliore? Nessuna speranza. Se non fosse stato per un parrucchiere, che era il compagno di un mio caro amico avvocato, io non avrei mai conosciuto mia moglie. Tempo dopo, ho pure ricambiato il favore. Ma all’amico avvocato (la cui relazione col parrucchiere era intanto finita). Ho organizzato un aperitivo con un bel po’ d’altre persone solo per fargli conoscere quello che un giorno sarebbe diventato… suo marito. Cupido, a noi, ci fa le pippe. Si, si, pure quelle].
Dopo appena un isolato, il furgone UPS si ferma di nuovo. Nulla di strano. Ormai la gente compra di tutto, in rete, e si spedisce di tutto. In qualunque tratto di strada, anche nei quartieri più periferici, i corrieri battono ogni numero civico come una volta era solo lavoro dei postini. L’autista con cui avevo appena scambiato due parole scende dal suo mezzo e si prepara all’ennesima consegna della sua giornata. Decido di raggiungerlo e aspettarlo.
Ci presentiamo, lui si chiama Elvin. E no, non pensa che io sia un ladro.
“Non hai la faccia! E poi, in genere, chi tenta di rubare aspetta che il portellone del furgone sia aperto e che io sia distratto.”
L’unica cosa che posso rubargli oggi pomeriggio è un po’ di tempo. Non troppo, ché le consegne chiamano. Ma si capisce che dagli occhi di Elvin devono sprizzare energia e positività, anche se sono mascherate dietro i suoi occhiali da sole.
“Mi fa piacere fermarmi a parlare. Ho altri amici italiani qui nel quartiere”, dice mentre gesticola proprio come fosse anche lui un italiano qualunque. “Ehi, non ti offendi, vero? Non voglio prendere in giro nessuno, anche quando scherzo e provo a dire delle cose in italiano. Mi piace davvero l’Italia.”
No, tranquillo, non mi offendo. E poi, Elvin, noi italiani prendiamo sempre in giro tutti, siamo dei perenni commedianti. Qualcuno, prima o poi, dovrà pur ripagarci con la stessa moneta.

Nei miei ormai otto anni e mezzo di vita newyorchese non avevo mai incontrato un americano che mi dicesse di voler andare a Maranello. Quella di Elvin per l’Italia è passione vera. Che si estende, ovviamente, ad altre due sfere fondamentali dell’italianità. La prima, che sembra quasi universalmente condivisa da qualche miliardo di esseri umani, è la sfera del cibo. La seconda, condivisa comunque da qualche milione di maschi adulti eterosessuali sparsi a varie latitudini, è quella delle donne.
“Una volta in Italia”, continua Elvin, “voglio anche andare in Sicilia. Perché voglio provare la vera ‘sicilian square’. Lo so che la pizza siciliana fatta qui in America non è neanche lontanamente uguale all’originale.”
Non ha tutti i torti, Elvin. Lo sfincione è cosa assai diversa dalla pizza ricoperta di pomodoro che posso trovare a New York. Ma, se è per quello, nemmeno a Torino o Milano mangerai uno sfincione come quello che trovi a Ragusa o che ti potrebbero preparare i tuoi amici di Vittoria le cui nonne andrebbero santificate (citazione non casuale). La “sicilian square” dj L&B Spumoni Gardens qui a Brooklyn è buonissima, a prescindere da quanto siano stretti i suoi legami di parentela con la fetta che si trova in Sicilia. Personalmente, soprattutto negli ultimi anni di vita in America, ho smesso di cercare le versioni che più si avvicinano ai piatti italiani. Ho iniziato ad apprezzare, invece, il contributo originale degli italoamericani. Nel tempo le loro rielaborazioni di noti piatti regionali, saltando dalle pentole delle nonne alle cucine dei ristoranti da “red sauce”, sono diventate delle creazioni indipendenti dalle lontane origini italiane. Questa riscoperta delle tradizioni familiari degli immigrati (e non della madrepatria), è molto sentita in tante comunità. In tutta America, per esempio, sta dando luogo ad un’ondata di nuovi ristoranti aperti da giovani sino-americani, che propongono in chiave moderna e creativa le ricette imparate dai loro nonni e genitori.
A parte le macchine da corsa, la rispettiva sopportazione delle temperature tropicali e la pizza, nella breve chiacchierata c’è spazio anche per qualche aspetto più personale. Elvin sta venendo fuori da un divorzio recente. “Mi spiace davvero”, gli dico con sincerità. “Però, Elvin, sono sicuro che riu…”. Mi interrompe e ride: “ma allora non ti spiace! Sei contento! Aaaahh!!Aaahhh!!!”
Adesso. Lasciamo perdere la mia proverbiale presunzione. Conosco qualcuno da meno di dieci minuti, e già posso tranquillamente pontificare sul suo luminoso futuro dopo un matrimonio di cui non sospettavo nemmeno l’esistenza. Il fatto che Elvin venga fuori da una separazione recente mette comunque in una luce tutta particolare la sua domanda successiva.
“Secondo te, qual è il posto migliore per conoscere delle donne italiane?”
Occhei, Signore e Signori, prendete posto, accomodatevi. Questa domanda va un bel po’… come dire… contestualizzata. Se la supercazzola non vi convince, diciamo che metto le manine avanti. Vero che conosco ben poco Elvin. Ma possono mettere quelle stesse mani sul fuoco, e garantire che mentre discutevamo di donne e Italia non stavamo producendoci in una pessima replica di qualche aspirante maschio sotto-alfa, magari di quelli che fischiano o fanno complimenti non richiesti alle donne che incrociano per strada. Non dico che fossimo due dottorandi di sociologia alle prese con osservazioni sul territorio. Ma nella sua domanda, e poi nella mia risposta, c’era davvero solo il desiderio di… come dire… costruire un ponte tra due culture diverse, ecco. Quella di Elvin era genuina curiosità. Perché uomini e donne, in Italia e in America, si comportano seguendo regole implicite degli ambienti in cui vivono. La morale non è proprio la stessa, così come non sono simili i codici di comunicazione. Ma non vado oltre, ché non voglio scivolare più di così.
“Emilia Romagna, Elvin. Si torna sempre lì, nella stessa regione di Maranello”, gli rispondo senza il benché minimo segno di incertezza.
E la mia affermazione non è sorretta da chissà quale dato reale o anche solo da qualche argomento con un minimo di logica. Niente affatto. Trattasi di puro pregiudizio, bello e buono. Ora che ci penso, credo che la mia convinzione sia più figlia di qualche film pecoreccio di metà Anni Settanta che non frutto di esperienza personale diretta. Si, penso che memorie lontane de “La Bolognese” abbiano creato, almeno per me, il mito della maggior disponibilità delle donne emiliane. Poi, se anche fosse, dovremmo delineare i contorni di ‘sto concetto. Ho incontrato uomini che, al primo sorriso di una donna, dicevano: “ci sta, ci sta! Si, si, significa che ci sta…”. E io mi sono sempre immaginato milioni di donne impossibilitate a muovere anche solo impercettibilmente labbra e sopracciglia per non dare corda a qualche mentecatto. A questi Alvaro Vitali coi bicipiti facevano da contraltare quelli che erano rimasti a Monsignor della Casa, e pensavano che al ristorante il galateo prevedesse sempre e comunque di pagare anche il conto di tutte le ragazze del gruppo. Al confronto di costoro, mi ritengo un maschio dalla mentalità moderna, aperta, progressis….zzzzz… Come ogni maschio, etero o no, non disdegnerei d’appartenere alla categoria alfa-alpha-ἄλφα, non fosse altro per la minor fatica che farei nell’imporre il mio volere su tutti gli altri. In fondo, a pensarci, magari qualche tratto c’è pure… sono decisamente sicuro di me, non mi interessa molto quello che gli altri pensano del sottoscritto, sono piuttosto determinato… Ma è tutta questa attenzione al fisico, che proprio non fa per me. Depilarmi il petto? Far sparire le maniglie dell’amore? Se alpha dev’essere, che cavernicolo sia. Cosa c’entra tutto questo con le donne dell’Emilia Romagna? E chi lo sa! Sto solo divagando. Ho conosciuto donne di diverse regioni italiane, nemmeno così poche. Ma non rammento d’aver avuto alcuna relazione con donne emiliane. Insomma, sono l’ultimo a poter parlare.
Spiego ad Elvin che inizio ad essere vecchio (anche se lui ha poi solo dieci anni meno di me). Che da troppi anni vivo lontano dall’Italia, e che magari adesso le cose sono cambiate. Ma ricordo che nei rapporti tra uomini e donne c’è qualche freno in più rispetto all’America. Per una donna italiana non è mai stato facile vivere senza troppi pensieri la semplice avventura d’una notte. Perché quegli stessi uomini italiani, quelli che si lamentano dell’impossibilità delle loro conterranee, poi la definirebbero come una cagna in calore. Non so davvero se le donne emiliane abbiano meno problemi e relazionarsi con gli uomini. Voglio solo sperare che sia vera la fama di regione dalla mentalità aperta. Tutto qui.

Non ricordo come, ma tra un accenno e l’altro di vite personali, io e Elvin finiamo a parlare anche dei nostri nomi. Gli racconto che i miei genitori avevano letto il nome “Denis” su una rivista. Così adesso mi ritrovo un nome che adoro e che quaggiù mi fa sembrare un italo-americano. Poi, appena apro bocca, il mio marcatissimo accento italiano non lascia scampo. “Ma tu sei italiano! E il tuo accento va bene così”, dice Elvin mentre gesticola per rendere il concetto ancora più chiaramente italiano. “Lo sai che in realtà io mi sarei dovuto chiamare Elvis? Si, come il cantante. Mia mamma amava Elvis Presley e aveva scelto il suo nome per me. All’anagrafe hanno scritto Elvin per errore. Quando è tornata lì per farlo correggere, c’è stato più nulla da fare.”
Ho perso il conto dei minuti e una telefonata dice che a questo punto sono in ritardo. Adesso devo andare a recuperare la famiglia dal dentista, a qualche isolato da qui. Prometto ad Elvin che un giorno delle prossime settimane ci vedremo per pranzo a Gowanus, anche se lui vive nel Bronx e potremmo incontrarci anche lì. O almeno per un caffè, glielo devo. Lo saluto e scappo. Dopo qualche ora ricevo un messaggio con una foto. È Elvin. “Questo è il mio venerdì sera”, scrive. Nella foto si vedono chiaramente un sigaro e una bottiglia di Courvoisier. No, Elvis non ci avrebbe mai pensato.
Per il sigaro, passo. Ma per il cognac, ci sono sempre.